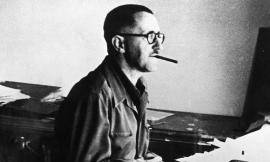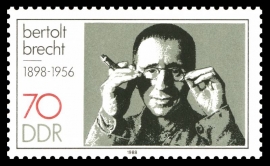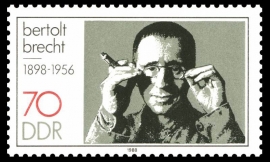Visualizza articoli per tag: brecht
Beata la società che non ha bisogno di eroi
Come fa notare acutamente Bertolt Brecht: se le istituzioni sono buone, l’uomo non deve essere particolarmente buono. Certo, allora gli si offre la possibilità di esserlo. Egli può essere libero, giusto e valoroso senza che egli o altri abbia a soffrirne.
Il ruolo del naïf e dell’allegoria nella poetica di Brecht
La rifunzionalizzazione del naïf doveva permettere, a parere di #Brecht, di abbattere la barriera che nel teatro tradizionale divideva il palcoscenico dalla platea. La Naivität, però, doveva essere inseparabilmente connessa all’effetto di #straniamento, che aveva la funzione opposta di impedire allo spettatore di confondere lo sguardo ingenuo con una presunta visione diretta, assoluta, metafisica della rappresentazione scenica.
Brecht e il ruolo dell’arte nella modernità
Recepire una lirica è un’operazione non meno di quanto lo sia, per esempio, il vedere e l’udire, anzi un’operazione che richiede un atteggiamento molto più attivo. Comporre poesie deve essere considerato un’attività umana, una pratica sociale, contraddittoria e mutevole al pari di tutte le altre, un’attività che è condizionata dalla storia e che a sua volta crea storia. La differenza sta fra rispecchiare e mettere uno specchio davanti agli occhi.
La concezione del realismo di Brecht
L’arte, per Brecht, non si limita a riprodurre la realtà, ma opera una sua trasposizione in forma che è allo stesso tempo una trasmutazione nella verità, se solo entrando nell’orizzonte di senso dell’opera il reale diviene “dominabile”, la forma, da parte sua, non può essere considerata come dotata in sé di senso prima ancora di realizzarsi nella mediazione con il proprio contenuto.
Brecht, Lukács e l’arte realistica
Tanto il realista quanto l’idealista offrono riproduzioni della realtà e pensieri. L’idealista tuttavia parte da un ideale di bellezza o da un ideale artistico, mentre il realista confronta continuamente gli ideali con la realtà e rettifica continuamente le immagini di quest’ultima.
Critica e immaginazione in Brecht
Nel mondo moderno, di fronte all’apparente irreversibile decadenza di ogni ideale, anche il più acceso ottimismo della volontà appariva contrastato da un profondo scetticismo della ragione, che sembrava negare a Brecht ogni compensazione estetica e rifiutare ogni ricomposizione delle contraddizioni del reale nell’orizzonte di senso della forma, per il carattere necessariamente soggettivo, volontaristico che questa operazione avrebbe comportato.
Brecht e l’arte moderna
Per sottrarsi a quell’annichilente processo di “museificazione”, che ha già privato gran parte dell’arte del passato del suo senso e della sua originaria valenza veritativa, l’opera d’arte moderna deve dimostrarsi capace di adeguarsi a un’epoca a essa ostile, un mondo che sembra non solo aver perduto ogni parvenza di innocenza e ingenuità, ma anche ogni nostalgico ricordo di esse.
Arte, riflessione e godimento estetico in Brecht
Se gran parte dell’arte tradizionale appariva destinata a una lenta, ma irreversibile agonia, ben diverso era, a parere di Brecht, lo stadio di salute dell’arte dell’inzwischenzeit, cioè dell’espressione artistica appropriata all’epoca della morte della poesia, una rappresentazione artistica fondata su di una solida base riflessiva e “sentimentale”, nel senso schilleriano del termine.
Brecht e la crisi dell’arte nella modernità
La scarsa sistematicità delle riflessioni di Brecht sull’arte rende difficile occuparsene senza aver individuato un punto di vista muovendo dal quale sia possibile reinterpretare, dare forma a questo magmatico materiale. Intendiamo, perciò, cercare di mostrare la ricchezza delle osservazioni di Brecht muovendo dall’analisi di una singola problematica: la crisi della rappresentazione artistica nella modernità.
Brecht, l’ironia e il dover essere del senso
In un mondo che, con la rinuncia a ogni sanzione sovratemporale e sovrumana del senso, ha finito per smarrire la sua stessa essenzialità, il carattere di obiettività con cui l’opera si oppone a questo smarrimento non può limitarsi a ratificare, pavidamente, l’incapacità dell’uomo a penetrare fino in fondo la realtà.