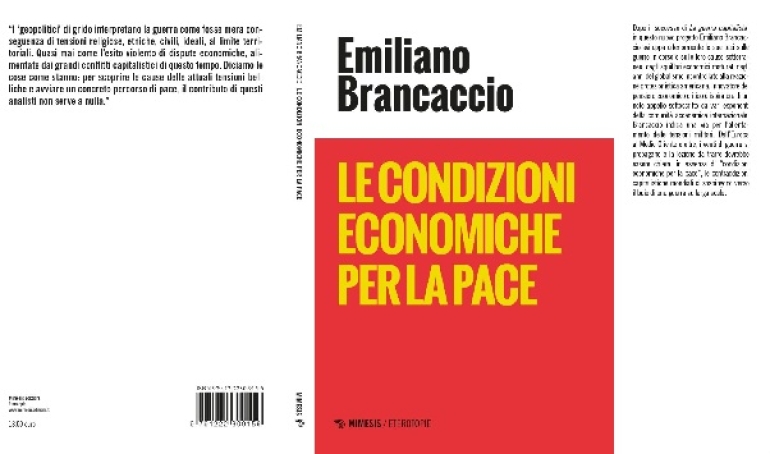Dall’inizio della guerra in Ucraina, che possiamo definire come uno scontro imperialista tra la NATO e la Russia per interposta nazione, molti tabù sono stati infranti. Tra questi, la possibilità di una guerra mondiale che coinvolga direttamente l’Europa, con il rischio addirittura di un conflitto nucleare. Se solo pochi anni fa parlare di tali scenari avrebbe potuto attirare l’attenzione dei servizi sanitari per un eventuale TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio), oggi, dopo tre anni dall’invasione russa, sono i leader europei stessi a parlare apertamente di riarmo, economia di guerra e della necessità di un riequilibrio globale tra le grandi potenze economiche.
In questo contesto, diventa urgente affrontare la questione della pace. Tuttavia, come giustamente sottolinea Brancaccio, per farlo è necessario comprendere le cause materiali alla base di questi conflitti, che definiamo di stampo imperialista. Il suo libro si distingue proprio per questa capacità di analisi, inquadrando le dinamiche della guerra attraverso le leggi di tendenza del capitalismo, che, seppur complesse e dialettiche, rappresentano le radici profonde dei conflitti attuali.
Questo approccio si contrappone nettamente al racconto mainstream, che spesso attribuisce le cause delle guerre a fattori sociologici, psicologici o persino razziali, tralasciando completamente gli aspetti economici, che sono invece la sostanza del problema. Il libro di Brancaccio merita dunque elogi e diffusione, non solo perché affronta le cause materiali della guerra, ma anche perché tenta di generalizzare queste dinamiche, distinguendo tra aspetti locali e globali.
Tra gli aspetti locali, troviamo il controllo dell’Ucraina, con le sue immense pianure di terra nera (tra le più fertili al mondo), le miniere e le terre rare. Queste risorse, se sfruttate con tecniche avanzate, potrebbero valere molto più dell’attuale PIL del paese. Tra gli aspetti globali, invece, emerge il rapporto tra paesi creditori e paesi debitori, che Brancaccio e i suoi collaboratori identificano come l’aspetto principale e il nucleo centrale della crisi attuale. Secondo questa analisi, tutte le guerre in corso, compresa la tendenza verso una guerra mondiale, hanno un responsabile preciso: il grande squilibrio tra paesi creditori (principalmente la Cina) e paesi debitori (soprattutto gli USA).
La Cina, in quanto principale creditore mondiale, sarebbe ormai pronta ad acquisire capitali occidentali secondo il modello liberale classico, in cui il più forte "mangia" il più debole. Questo processo rientra in una delle leggi di tendenza del capitalismo: la centralizzazione dei capitali. Fino a oggi, questa legge marxiana è rimasta prevalentemente teorica, ma gli autori sostengono che ora sia possibile dimostrarla empiricamente, grazie a strumenti di calcolo avanzati come la network analysis, che permettono di elaborare grandi moli di dati.
Storicamente, la centralizzazione dei capitali è stata guidata dalle potenze occidentali, ma oggi è un processo conteso, con la Cina che potrebbe assumerne il controllo. È proprio in risposta a questa minaccia che gli USA hanno innalzato barriere doganali e adottato politiche protezioniste, come il cosiddetto friend-shoring, che esclude i capitali cinesi e russi dalla spartizione del mercato globale. Questo scontro tra capitali, nel contesto della centralizzazione, rappresenterebbe la base materiale delle guerre in corso.
A questo proposito, sarebbe utile approfondire il tema del multipolarismo e chiedersi se questa sia la forma assunta dall’imperialismo nella fase attuale. La centralizzazione dei capitali, infatti, non avviene in modo lineare, ma in correlazione con un’altra legge del capitalismo: lo sviluppo diseguale. In archi temporali lunghi, le dinamiche economiche si evolvono in modo contraddittorio, portando al declino di alcune potenze e all’ascesa di altre. Contrariamente alle teorie ultraimperialiste, che immaginano il dominio pacifico dell’unico grande capitale al comando, la realtà storica mostra un continuo sorgere e perire di poli economici in conflitto tra loro.
In questa fase, il multipolarismo non rappresenta uno scontro tra capitalismo e socialismo, ma piuttosto un aspetto della putrefazione del capitalismo nella sua fase monopolistica. La ricerca della pace, secondo gli autori, richiederebbe un equilibrio tra questi poli, attraverso un piano keynesiano che gestisca la conflittualità.
Nel capitolo “Dalla competizione economica allo scontro militare”, Brancaccio risponde alla domanda su come sia possibile pacificare i rapporti internazionali. La sua proposta è quella di recuperare la logica del piano Keynes del 1943, che ispirò gli accordi di Bretton Woods e i controlli sui movimenti di capitale del dopoguerra. Secondo lui, servirebbe un piano di “gestione politica coordinata degli squilibri economici e finanziari globali, che non può essere lasciato né alle forze anarchiche del mercato né a politiche protezionistiche non concordate”.
Tuttavia, Brancaccio riconosce che questa proposta potrebbe risultare astratta e difficilmente realizzabile. In un altro passaggio del libro, apre la discussione su un’altra possibilità: la “soluzione leniniana”, che punta alla rivoluzione. Questo dualismo tra riforma e rivoluzione rappresenta forse l’unico punto debole del libro. Come già sottolineato da Rosa Luxemburg, le grandi riforme non sono concessioni spontanee delle borghesie illuminate, ma il risultato di una pressione rivoluzionaria.
Un paese imperialista, infatti, non può che perseguire politiche imperialiste, indipendentemente dal partito borghese al governo. Porre come alternativa la soluzione keynesiana a quella leniniana appare dunque un errore. Lo stesso Brancaccio riconosce che le politiche keynesiane del dopoguerra furono possibili solo grazie al contesto straordinario delle due guerre mondiali e alla presenza del “pungolo comunista” rappresentato dall’Unione Sovietica.
Riprendere la categoria della centralizzazione dei capitali è uno dei meriti principali di questo libro. Tuttavia, è importante notare che questa legge può (o forse deve) essere intesa come una “contro-tendenza” alla crisi da sovrapproduzione. Se da un lato la centralizzazione cerca di contrastare la caduta del saggio di profitto, dall’altro, nel lungo periodo, acuisce le contraddizioni del sistema.
Marx, nel secondo volume de Il Capitale, affronta questo tema attraverso l’analisi dell’accumulazione su scala allargata, mentre Rosa Luxemburg e Lenin lo sviluppano ulteriormente, rispettivamente sul piano teorico ed empirico [1]. La centralizzazione dei capitali, quindi, può essere compresa appieno solo se collegata al processo più generale dell’accumulazione e alla caduta tendenziale del saggio di profitto.
In conclusione, questo libro rappresenta un faro in tempi bui, offrendo una chiave di lettura materialista delle dinamiche economiche e politiche che stanno dietro ai conflitti attuali. La sua lettura è non solo consigliata, ma necessaria per chiunque voglia comprendere le radici profonde della crisi globale e immaginare una via d’uscita.
[1]La Luxemburg affronta il problema dell’accumulazione allargata sul piano teorico e la espone nel testo L’accumulazione del capitale, mentre Lenin affronta la tematica dell’imperialismo più da un punto di vista sperimentale cioè a stretto contatto con i dati reali.