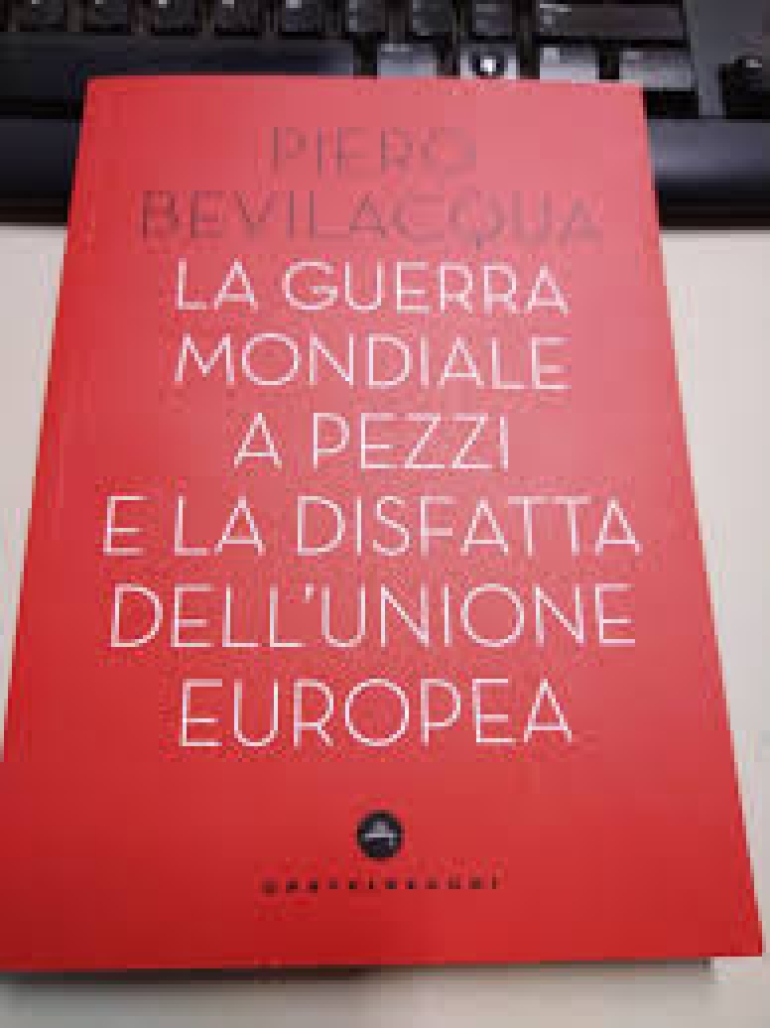È stato a suo tempo papa Bergoglio a coniare l’espressione con la quale Piero Bevilacqua sigilla questo intenso e puntuale excursus sull’accelerazione drammatica delle vicende internazionali a seguito dello scoppio della guerra tra Repubblica Federativa Russa e Ucraina.
Quello stesso Bergoglio, che non esitò, ristabilendo un minimo di precisione e decenza nel dibattito dominato dalla facile e indecorosa narrazione televisiva (giocata sulla piatta semplificazione tattica dell’ “aggredito” e dell’ “aggressore”), a suggerire l’immagine, prudente ma efficacissima, valida anche come elementare suggerimento eziologico, di quell’ “abbaiare della NATO alle porte della Russia” [1] insistito e protervo, che riconduceva l’intera vicenda alla sua banale scaturigine storico-fattuale.
Le parole del Capo della Chiesa cattolica descrivevano in modo bonariamente impolitico e impressionistico quel “vero e ostentato accerchiamento” (Bevilacqua, p. 51), consapevole e proditorio, cui la Russia (a stare alle tante voci insospettabili, anche di area anglosassone, che si sono pronunciate sulla sostanza degli eventi) era soggetta almeno dai primi anni del nuovo millennio (in realtà, dal 1994). Da quando cioè, dopo la ampie, generose e reiterate rassicurazioni dei vertici della politica occidentale (in versione europea, quanto in quella statunitense), aveva preso avvio una certa qual direttrice geo-politica, che da ovest verso est segnava in implacabile e vistosa progressione il diretto contatto con i confini vivi dell’ex-Unione Sovietica, ormai spogliata di quelle realtà statuali cuscinetto, che andavano intrepidamente passando rapide dall’antica sudditanza alla compagine eurasiatica, a quella, apparentemente più confortante, del “mondo libero” (secondo il lemma invalso nella lunga stagione della guerra fredda, che è tornato a riaccreditarsi).
Scritto e dato alle stampe con ogni evidenza a cavallo tra l’elezione e l’insediamento di Trump, dunque prima che il ruvido reazionario imprimesse una svolta fulminea a molte delle politiche del predecessore democratico, il testo dello storico dell’età contemporanea e collaboratore del “manifesto” svolge una serrata e documentata ricognizione della catena di eventi che sembra al momento “concludere” nell’apertura di una prospettiva di pacificazione (a gestione Usa-Federazione russa), con un’Europa spiazzatissima e stordita, rimasta col proverbiale cerino in mano, che favoleggia progetti di inedito protagonismo militare “unitario”, per surrogare quello che appare il venir meno dell’alleato d'oltre Atlantico, mentre brancola alla ricerca di una linea credibile (quando non dà fondo al delirio di onnipotenza di leader ormai privi di credibilità o qualsivoglia sostegno popolare, come il “napoleonico” Emmanuel Macron). La medesima, che farfuglia scomposta e delirante di piani di riarmo, che apparirebbero esilaranti, se non riguardassero (anche) la Germania riunificata, oggi sotto lo sguardo obliquo dell’ex organico di Blackrock, l’ineffabile Friedrich Merz.
Bevilacqua ripercorre analiticamente le tappe dell’escalation atlantica, mettendo rigorosamente in fila tutte le “stazioni” che hanno condotto all’attacco russo all’Ucraina, storicizzando un evento che nella grande stampa di sistema sorge quasi dal nulla come effetto, a seconda degli interpreti, dell’insopprimibile e demoniaca pulsione imperiale di una Russia tornata zarista (ma anche erede sotto traccia dell’antica disposizione sovietica al dominio) o delle ambizioni “millenaristiche” dell’attuale Presidente (sul quale pure fiorirono dalle nostre parti, dopo il 24 febbraio 2022, le più disparate, amene e fantasiose letture “cliniche” e mostrificanti, attingenti addirittura allo studio della fisiognomica [2]).
Il giudizio di Bevilacqua è limpido e perentorio, in linea con quella parte degli osservatori, che non ha esitato a denunciare, anche negli Stati Uniti, la strumentalità e il carattere ideologico di tutta l’operazione culturale di copertura di un’aggressione differita e indiretta alla Russia, massicciamente giocata sul terreno dell’inversione narrativa dei fatti, tesa a riaccreditare l’arcigna, e tradizionale, visione dell’”Orso” orientale, che dominava già nel corso dell’Ottocento, dai tempi del “Grande gioco” nell’ Asia centrale (con quegli stessi inglesi, cui non par vero, oggi, tornare in campo a raccogliere le briciole concesse dal partner americano).
Ma la forza, la novità e l’originalità del volume dello storico, ben al di là dell’analisi di fase, è la robusta saldatura con l’immenso e il rimosso (almeno da parte dell’informazione ufficiale) pregresso di questa vicenda, che di esso rappresenta solo l’estrema e circostanziale perifrasi temporale. Si tratta della lunga e consolidata tradizione e pratica di costruzione muscolare dell’impero, a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale (ma, a ben vedere e a rigore, già dalla seconda metà del XIX secolo, quando la visionaria farneticazione “eccezionalista” nord-americana, pompata della retorica auto-celebrativa del Manifest Destiny, orientava i primi passi di una sanguinosa traiettoria di espansione planetaria [3], che sul lungo periodo avrebbe surrogato il progressivo decadere della Pax Britannica). Così, Bevilacqua allinea in modo essenziale e persuasivo quanto sui manuali di storia trova la sua sintetica, ma veridica, trattazione (cui avrebbero potuto ma soprattutto dovuto già accedere i loquacissimi “esperti” televisivi di geo-politica), delineando la vera e propria coazione a ripetere di un Paese, gli Stati Uniti d’America, e di una politica estera, letteralmente irretiti da un’irresistibile pulsione espansionistica, tutta legata al coacervo di interessi materiali, che ne ispirano e motivano l’esistenza stessa [4], ma trasudanti retorica e buoni sentimenti, di facile presa popolare. Dati notissimi ai più (oltre che vissuti tragicamente sulla propria pelle dai tanti popoli che ne hanno portato il peso sanguinoso), ma che, messi in fila e connessi sul terreno storico-politico, descrivono in modo inequivoco l’anima profonda di quella compagine, il filo rosso dell’imperialismo americano, gagliardamente cresciuto sul piano inclinato del colonialismo europeo, con le due guerre mondiali asceso alla leadership planetaria. Le cui “imprese”, il crollo del blocco orientale, con le sue pesanti ricadute politico-culturali, ha confinato nel dimenticatoio, in un fase di strutturale rimozione collettiva del passato, di banalizzazione, o di sua riduzione all’inessenzialità, dentro un immaginario da “fine della storia”, che ne elide il corso reale e per ciò stesso opera per paralizzare il futuro. Ed è per questo che il libro di Bevilacqua svolge una funzione di igienico ripristino di una memoria, vademecum dal fortissimo impatto pedagogico e culturale, teso a ristabilire verità e buon senso analitico. Esso allarga la visuale storica e spaziale dell’agire sistemico, illumina i tratti di ferocia ed efferatezza arrogantemente messi in forma nelle varie sedi del dominio a guida Usa, connettendone le occorrenze ed evidenziandone la ferrea logica ispiratrice, “l’anticomunismo come instrumentum regni dell’Impero”[5]. Le cui numerose tappe e figure sono condensate e condensabili nel “metodo Giacarta”, l’epopea a rovescio del letterale sterminio dei comunisti dell’arcipelago alla metà degli anni Sessanta, strategicamente risoltosi nella “più grande vittoria dell’Occidente nella Guerra Fredda” (p. 67) [6]. Una sorta di cieca inerzialità delle politiche estere americane, dunque, irretite nella coazione a ripetere imperiale, che dopo la morte di Franklin Delano Roosevelt si impenna nella difesa accanita di un abusato “mondo libero” dal demone sovietico, e che attraversa con diverse sfumature presidenze democratiche e repubblicane, solidali nel confermare un’ormai imbarazzante centralità e palesemente incapaci di mascherare l’impasse storico-epocale, in cui versa una società in cui precipita persino l’aspettativa di vita, mentre cresce la mortalità infantile. Siamo al cospetto, ribadisce alla fine l’Autore, della “fine dell’americanizzazione del mondo” (pp. 93-104).
Ma la riflessione sui fatti più recenti, se impone a Bevilacqua di impegnarsi in una disamina più estesa delle relazioni internazionali (comprendente, com’è ovvio, gli ultimi venti anni della Federazione russa dopo il tracollo del “fantoccio” El’cin e il nuovo protagonismo impresso da Vladimir Putin), non può non concentrarsi sull’Unione Europea, di cui l’Autore esamina, non gli “errori” (che presupporrebbero un percorso a suo modo coerente con certe indicazioni originarie dei “fondatori”), ma la lunga decomposizione, legata al imprescrittibile vizio d’origine: “fondata sulla sovranità degli antichi Stati del continente, ha ceduto il proprio potere e prestigio a un altro Stato, una forza straniera al di là dell’Oceano”, naturalmente l’alleato che ne avrebbe garantito la sicurezza (come da vulgata) contro i pericoli provenienti da Oriente. Cosicché, nella lunga traiettoria che parte dall’89, “l’Unione si è spenta come comunità sovranazionale [ cedendo ] la gestione della politica estera a un’organizzazione militare, la NATO”, a trazione essenzialmente americana. Da principio e nelle intenzioni “configurazione sovranazionale concepita come entità terza rispetto ai due blocchi della Guerra Fredda (…), la nuova sovranità cosmopolitica creata per un nuovo ordine internazionale, è moralmente e politicamente morta” (p. 129). Anche prima delle scellerate posizioni assunte sulla guerra in Ucraina e sulla vicenda israelo-palestinese, (sulle quali avrebbe in teoria potuto rivendicare una soggettività da battitore libero e la titolarità di decisive iniziative di mediazione), essa aveva fatto propri gli aspetti peggiori di un ethos e di un’ideologia d’importazione, applicati in spregio di una lunga tradizione di welfare e di modello di civiltà, che l’avevano in qualche modo distinta dalle barbarie di mercato provenienti dagli Usa, ma anche grondavano delle memorie (e delle responsabilità) di due guerre mondiali - delle guerre mondiali. Al contrario, l’Unione ha preteso di competere attivamente con l’alleato statunitense sul suo stesso terreno culturale e socio-economico, scavando una voragine con popolazioni che, lungi dal rappresentare nelle forme di una democrazia compiuta, essa confina nel limbo della irrilevanza decisionale (quando non criminalizza superficialmente, paventandone in modo sbrigativo la curvatura razzista o addirittura neo-nazista, senza coglierne la sostanza profonda della disaffezione o dell’esplicita contrarietà alle politiche materialmente implementate dai gruppi dirigenti).
Anime belle parlerebbero dunque di un fallimento storico, se non fosse che ai vari livelli dei centri decisionali del Continente, nei gangli burocratici e nella filosofia dispiegata, l’Europa non solo da tempo esibisce un’inequivocabile anima classista e un’organicità a ritmi e modi del capitale finanziario, ma riesce persino a disseppellire un’isterica (e antica) vena militaristica, tale da mettere in discussione persino i dogmi di bilancio e da derogare agli (un tempo) imprescrittibili imperativi della moneta, necessitati dalla supervisione di impersonali, sacralizzati mercati. Alla cui gestione presiede il dominus riconosciuto, l’Uomo del destino degli equilibri di sistema, il “salvatore”, quell’ecumenico Mario Draghi, il cui solenne Rapporto sul futuro della competitività europea [7], paradossalmente, rappresenta più un’”autorevole certificazione di morte dell’Unione”, un “ferale referto”, che un’originale proiezione su un futuro praticabile. “Non a caso esso presuppone, quale condizione perché l’Europa possa salvarsi, investimenti e sforzi concertati tra gli Stati membri di pressoché impossibile realizzazione” (p. 130). Nella scelta e nella delega a cotanto “Salvatore c’è tutta la disperazione politica dell’élite europea” poiché “eccellente manager [ma] mediocre politico, subalterno all’establihment e ai voleri di Washington”, Draghi è “incapace di uscire dall’orizzonte in cui è chiusa l’Unione Europea”. D’altra parte la sua esperienza alla guida di una compagine governativa nostrana, allorché aveva goduto “di un consenso totalitario”, e quando avrebbe potuto dar prova di una visionaria capacità di “risollevare le sorti del Paese”, Draghi (già famigerato liquidatore dell’economia pubblica italiana, quando era direttore generale del Tesoro), “che pure mise mano alla struttura del fisco”, e a fronte della gravità dei problemi di questo Paese, produsse “un mostriciattolo, abolendo addirittura un’aliquota invece di moltiplicarle per ‘n’ come sarebbe stato necessario” (p. 132). Il Rapporto “motiva tutti gli obiettivi indicati all’Unione e ai governi con una sola finalità di prospettiva: la crescita economica”. In tal senso, l’Atto draghiano, “altamente rappresentativo della cultura dominante”, esorta a “marciare come prima, sul sentiero di sempre, correggendo gli errori, […] aggiustando il tiro, ma per continuare a correre sempre più speditamente verso il nulla” (p. 136). E alla fine, il documento che dovrebbe rilanciare l’Unione Europea si conferma “esemplare quale distillato di una cultura vecchia, obsoleta, quella che condanna l’Occidente al suo declino e minaccia al tempo stesso la sopravvivenza della specie sulla Terra: la tradizione di pensiero che ignora la natura quale fondamento di ogni attività di produzione e consumo” (p. 137).
L’insistenza di Bevilacqua su Draghi non è casuale. Essa prende di mira ed esplicita la globalità di un ethos egemone, che nel “mediocre politico” trova condensata una spregiudicata prassi predatoria consustanziale all’intima disposizione delle oligarchie neo-liberali, che si estende dalla società e dai rapporti sociali all’ambiente fisico, nell’assunzione dell’economia (capitalistica) a natura, ipostasi di un rapporto patologico della specie con se stessa e con la condizioni oggettive di produzione e riproduzione della vita. La cancellazione ideologica dello sfondo dell’attività umana diviene così lo spazio aperto di una pulsione nichilistica, con la quale il moderno capitalismo decreta, con la propria, la “programmata” estinzione dolosa di ciò di cui si proclama “valorizzazione” [8]. La celebrazione della centralità e sacralità del profitto tout-court è l’apoteosi dell’anima borghese e la cifra della sua indifferenza ad altri che non sia la propria bulimica anomia.
A fronte di questo orizzonte, può apparire patetico il richiamo alle (ir)responsabilità del pigmeo europeo. Eppure il Vecchio continente, nei tentacoli infecondi e ottusi dei suoi tecnocrati ha messo in forma una regressione imponente della società e, nel negare la parte migliore della sua vicenda tormentata [9], si è consegnato al più vieto economicismo, scaricando sui settori più deboli della popolazione il peso feroce di un’abdicazione integrale al feticcio del mercato, oggi persino all’incantamento surreale di una guerra possibile (contro… la Russia).
Il campionario delle sue malefatte e delle proditorie iniziative in ogni campo della vita associata è da Bevilacqua sinteticamente ma efficacemente rappresentato e perimetra un panorama di devastazione in atto, che prefigura ulteriori, drammatici smottamenti involutivi.
Ma lo storico non rinuncia all’ottimismo della volontà e a un marxiano volitivo impegno della prassi. E mentre mena sciabolate a tic e miserie di un’Italietta variamente declinata e alle sue macchiette lillipuziane dalle tante sfumature cromatiche, non rinuncia a “immaginare strategie possibili per invertire il corso di una regressione che non è soltanto economica e sociale” (p. 169), a evocare le coordinate di un genuino riformismo, così come al progetto di “tenere accesa la fiammella di un nuovo progetto continentale” (p. 181). Sa che “occorre rompere in qualche punto l’ordito neoliberista per smagliare l’intera rete del dominio, di un progetto ormai disperato che vede il suo futuro in una economia di guerra e nell’invivibilità umana sulla Terra” (p. 181). Segnala utilmente suggestioni, figure, forze e progetti ispirati alla migliore letteratura critica e “utopica” (come il piano refrigerante di una “costituzione della Terra” [10]). Richiama alla centralità del conflitto, e si ostina a ricordarci che “l’alternativa c’è” (pp. 169-198). Vogliamo e dobbiamo credergli, consapevoli che il tempo gioca per l’avversario e che i segni di un’unificazione dei dannati della Terra rendono quella “fiammella” ancora soltanto un pallido bagliore etico.
Note:
- Mentre si diceva “semplicemente contrario a ridurre la complessità alla distinzione tra buoni e cattivi, senza ragionare su radici e interessi, che sono molto complessi”, nell’intervista a Luciano Fontana, Corriere della Sera, 3 maggio 2022.
- In prima fila, naturalmente, il quotidiano di piazza Indipendenza, soprattutto nei primi mesi della congiuntura militare.
- Ispirato dal testo fondativo dell Contrammiraglio Alfred Thayer Mahan (1840-1914) The Influence of Sea-Power Upon History (1890).
- “Se non si tiene in considerazione l’incombenza militare degli Stati Uniti sull’intero pianeta nulla si può comprendere delle vicende del nostro tempo” (p. 9).
- Titolo del Terzo capitolo del libro (pp.54-74).
- Si legga, al riguardo, il capitale Il metodo Giacarta. La crociata anticomunista ed il Washington e il programma di omicidi di massa che hanno plasmato il nostro mondo (Torino, 2021) del giornalista statunitense Vincent Bevins.
- Mario Draghi, settembre 2024, https:///bit.ly/3VxgCBM.
8.“… una relazione cannibale, estrattiva, che consuma sempre più ricchezza biofisica per accumulare sempre più ‘valore’, trascurando le ‘esternalità’ ecologiche. Non a caso, insieme al capitale cresce una montagna sempre più grande di eco-detriti…” Nancy Fraser, Capitalismo cannibale. Come il sistema sta divorando la democrazia, il nostro senso di comunità e il pianeta, Roma-Bari, Laterza, 2023, pag. 93.
- Di cui, a suo modo, fa parte anche il famoso/famigerato Manifesto di Ventotene, a patto che lo si sottragga ai piagnistei ipocriti e omissivi dei nostrani “riformisti”.
- Luigi Ferrajoli, Per una Costituzione della Terra. L’umanità al bivio, Milano, Feltrinelli, 2022.