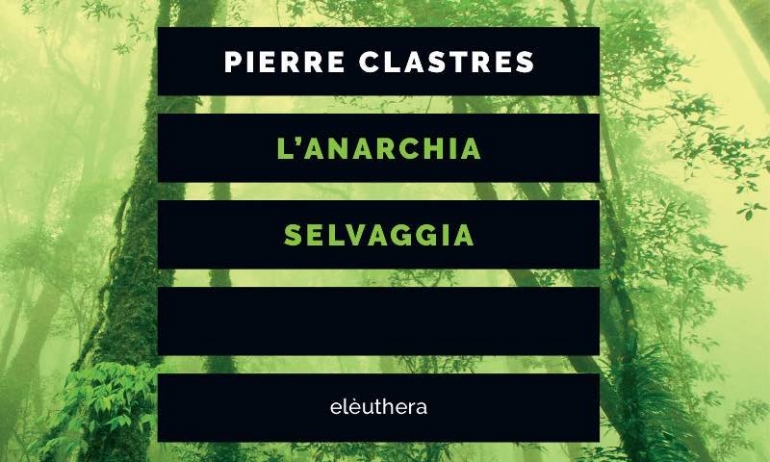La seconda ristampa del libro “L’anarchia selvaggia” di Pierre Clastres (Elèuthera, Milano 2017), un antropologo francese scomparso prematuramente nel 1977, ci consente di tornare a riflettere su due problemi centrali: il sorgere del potere e la distinzione / differenza tra società centralizzate e società acefale (nel linguaggio dell’autore “divise” e “indivise”).
Si tratta ovviamente di due problemi capitali, che non hanno esclusivamente una portata teorica, ma che costituiscono anche le problematiche all’interno delle quali si dispiegano le nostre vite quotidiane, scontrandosi con gli ostacoli che il potere e la divisione in dominanti e dominati frappongono alla nostra legittima realizzazione e alla nostra ragionevole richiesta di riconoscimento da parte degli altri.
Affrontando questi problemi Clastres, che fu forse l’allievo preferito di Claude Lévi-Strauss, cui tuttavia non risparmia critiche, talvolta assume il tono nietzschiano di colui che scopre qualcosa a cui nessuno prima ha mai pensato, quando invece purtroppo per il nostro amor proprio spesso ci limitiamo a ripetere qualcosa che qualcuno sia pure da noi dimenticato ha già detto. Ma questo è un po’ un difetto di tutti quelli che si sono richiamati alla cosiddetta French Theory, ossia il poststrutturalismo, che nella sua foga distruttiva ha accantonato la misura e la prudenza.
Il principale ispiratore della riflessione di Clastres è Étienne de la Boétie (1530-1563), affettuoso amico di Michel de Montaigne (1533-1592), il quale probabilmente a solo 18 anni scrisse il famoso “Discorso sulla servitù volontaria”, diffuso clandestinamente con il significativo titolo “Il Contr’Uno”, divenuto un classico del pensiero anarchico e un’imprescindibile lettura ancora oggi.
Nota è la tesi sostenuta in questo pamphlet e che può essere espressa con le stesse parole di La Béotie, il quale scrive a proposito della sudditanza degli uomini a un tiranno / sovrano e della possibilità di liberarsi di lui: “…non c'è bisogno di combattere questo tiranno, di toglierlo di mezzo; egli viene meno da solo, basta che il popolo non acconsenta più a servirlo. Non si tratta di sottrargli qualcosa, ma di non attribuirgli niente; non c'è bisogno che il paese si sforzi di fare qualcosa per il proprio bene, è sufficiente che non faccia nulla a proprio danno. Sono dunque i popoli stessi che si lasciano, o meglio, si fanno incatenare, poiché col semplice rifiuto di sottomettersi sarebbero liberati da ogni legame; è il popolo che si assoggetta, si taglia la gola da solo e potendo scegliere fra la servitù e la libertà rifiuta la sua indipendenza, mette il collo sotto il giogo, approva il proprio male, anzi se lo procura”.
La domanda che sorge spontanea e che riguarda anche noi contemporanei è questa: perché gli uomini rinunciano alla loro libertà naturale e si fanno servi? Perché si sottomettono anche senza ricavarne vantaggi, spesso addirittura a rischio della loro stessa vita? La Béotie risponde semplicemente: perché lo desiderano, senza chiarirci però se tale desiderio (qualcuno ha parlato di pulsione di autoassoggettamento) sia innato o acquisito.
Risulta sicuramente interessante che La Béotie spieghi il sorgere del potere con un processo che si dipana dal basso: sono gli stessi uomini che si sottomettono, rinunciando alla loro libertà naturale perché educati dall’abitudine a servire e perché ingannati dai diversi livelli di potere che si dipartono dal tiranno (i favoriti, i loro subordinati diretti e indiretti, e via via discendendo fino agli strati più bassi). L’abitudine si sovrappone così alla nostra vera natura e obnubila la ragione la quale ci insegna che siamo nati tutti uguali e liberi, forse però con quel ferale desiderio di sottomissione. È interessante questo tipo di spiegazione, perché in genere viene adottato il processo interpretativo inverso: sono coloro che hanno acquistato autorevolezza, magari per le loro funzioni religiose o sociali, che stabilizzano il loro ruolo e si trasformano in capi, magari anche nelle condizioni di tramandare il livello conquistato superiore a quello degli altri ai propri figli. E come Clastres ci spiega questo tipo di ragionamento è stato erroneamente applicato ai cosiddetti big men (capi) melanesiani, i quali – secondo una certa lettura - trasformandosi in centri di accumulazione dei beni li ridistribuiscono stabilendo relazioni clientelari, che col passare del tempo e con la stabilizzazione del potere acquisito diventano rapporti di sudditanza. Clastres rovescia il ragionamento: i big men, grazie anche al lavoro delle loro mogli, producono una grande quantità di beni che redistribuiscono tra i loro vicini, in cambio essi acquisiscono prestigio e si vedono attribuito l’importante ruolo di rappresentare la comunità nella sua totalità. Quando essi parlano, lo fanno a nome della comunità, ma non possono mai contraddire i desiderata dei loro compagni, perché non sarebbero più né ascoltati né seguiti, addirittura in caso di gravi contrasti potrebbero anche essere uccisi. Insomma, essi non sono capi veri e propri perché non hanno alcun potere e se si distinguono dagli altri è solo per il prestigio loro riconosciuto e per le qualità di essere generosi e buoni oratori.
Secondo l’antropologo francese, nell’analizzare quelle forme di organizzazione politica definite chefferies (in inglese chiefdoms, non esiste un termine in italiano) i suoi colleghi hanno commesso il grave errore di confondere il potere con il prestigio. Infatti, colui che viene considerato il capo non ha potere alcuno, ha solo uno smisurato desiderio di prestigio, che riesce ad accumulare grazie alla quantità di beni che redistribuisce. Se vuole mantener viva questa sua autorevolezza, egli deve costantemente pagare il debito che ha contratto con la società: “Prigioniero del suo desiderio di prestigio, il capo selvaggio accetta di sottomettersi al potere della società assumendosi il debito che istituisce ogni esercizio di potere”. Tuttavia, scegliendo questa via, il capo si trova ad essere bloccato e non può avanzare nella costruzione di un potere autonomo e indipendente dalla sua gente, la quale è ostile proprio alla realizzazione di questa possibilità. In questo senso, Clastres ribadisce che le società primitive [1] sono “società contro lo Stato”, ossia società che mettono in atto tutta una serie di strategie che hanno l’obiettivo di impedire la formazione di un organismo politico esterno alla società (2017: 131). Si potrebbe addirittura affermare che sono società di uguali, in cui prevale il potere diffuso o l’autogoverno, tratti propri della marxiana società comunista.
Queste considerazioni inducono Clastres a rifiutare l’interpretazione evoluzionista e continuista della storia umana identificata anche con il marxismo: i reami, sviluppatisi nei diversi continenti e caratterizzati dal fatto che la società diventa debitrice del re tramite i tributi e divisa in dominati e dominanti, non possono esser considerati il necessario sviluppo della chefferie, perché in essa non è permesso al capo trasformare in potere il proprio prestigio (2017: 130). Seguendo sempre il giovane La Béotie, che fu consigliere de Parlamento di Bordeaux e fu incaricato di portare avanti la politica di conciliazione religiosa tra cattolici e protestanti, l’antropologo francese scrive che le società primitive sono “indivise”, ossia formano un tutt’uno omogeneo e in quanto tali “impediscono al desiderio di potere e a quello di sottomissione di realizzarsi: sono macchine sociali rette dalla volontà di permanere nel proprio essere indiviso, che si istituiscono come luoghi di repressione dei cattivi desideri” (2017: 102, corsivo nel testo). E proprio in questo senso ripete con enfasi “sono società contro lo Stato”.
A questo punto sorge un altro quesito, non meno importante degli altri formulati in precedenza: se le società primitive hanno adottato espedienti per impedire il costituirsi di un organismo politico indipendente, come è possibile che esso sia conformato? Come è possibile che l’uomo rinunciando all’uguaglianza e alla libertà, abbia con ciò tradito la sua stessa essenza, alienandosi da essa? Secondo La Béotie tale tragico evento – malencontre egli dice [2] – fu un evento accidentale e irrazionale dal quale è scaturita la nascita del potere centralizzato e con esso dello Stato nelle sue varie forme (2017: 93). E purtroppo una volta che si è realizzato tale trapasso l’uomo nato per essere libero si snatura, regredisce, perde se stesso, entra in una fase di decadenza dalla quale è pressoché impossibile risollevarsi. Commenta Clastres: l’uomo diventa quello che è oggi, l’abitante delle società divise, l’individuo alienato ed oppresso, che ha rinunciato volontariamente ad essere ciò per cui è venuto al mondo (2017: 98-99).
Un altro aspetto importante messo in evidenza da Clastres riguarda più direttamente l’economia della società primitive, della quale era sempre prevalsa un’immagine distorta. Secondo quest’ultima la mancata produzione di surplus fa sì che esse abbiamo sviluppato una mera economia di sussistenza, una vera e propria economia della miseria. Avvalendosi di un noto saggio di Marshall Sahlins (L’economia dell’età della pietra, 1980), l’antropologo francese ribalta tale concezione, mostrando invece che in tali arcaici contesti vige l’economia dell’abbondanza ispirata al principio che è inutile accumulare risorse alimentari che non si possono consumare. Infatti, i cacciatori-raccoglitori e i protoagricoltori non sono degli anticipatori del manager capitalistico, che mira esclusivamente al profitto, e pertanto, quando hanno raggiunto una quantità di beni sufficienti alla loro riproduzione, si fermano e si dedicano ad altre attività come gli scambi, la ritualità, la guerra. Anche in questo caso, secondo Clastres, si tratta di una decisione: se volessero potrebbero produrre di più, ma non lo desiderano (Clastres 2017: cap. IV).
Ci sarebbero ancora altri interessanti aspetti della riflessione di Clastres da mettere in luce, ma non abbiamo lo spazio necessario, quindi ci avviamo alla conclusione proponendo qualche riflessione sulla polemica che egli conduce a più riprese contro il marxismo da lui identificato con il determinismo economicistico. Giudicherei tale polemica una battaglia di retroguardia dal momento che, per esempio, nel 1970 esce in Francia l’antologia curata da Maurice Godelier intitolata Sulle società precapitalistiche, dalla quale si può ricavare un’immagine assai complessa e variegata di queste forme di vita sociale che in particolare non si perpetuano secondo un processo univoco, unilineare e necessario, scandito unicamente dallo sviluppo delle forze produttive. Tale sviluppo appare invece necessario laddove si innesca una trasformazione qualitativa, un passaggio da un sistema sociale ad un altro, trasformazione che può anche non realizzarsi a causa dell’operato di controtendenze. Inoltre, e chiudo, non pare contraddittoria rispetto alla tesi centrale di Clastres l’idea di Engels, espressa nell’Anti-Dühring, secondo la quale “il dominio politico si è fondato sull’esercizio di una funzione sociale e che tale dominio politico ha continuato ad esistere per lungo tempo solo laddove ha mantenuto l’esercizio di tale funzione sociale” (in Godelier 1970: 244). Dal momento che alla fine lo Stato si è formato, evidentemente in qualche luogo la lotta contro di esso non è stata efficace e nella relazione dialettica tra le due tendenze (equilibrio ugualitario / prevaricazione) ha vinto la seconda, la quale successivamente ha costituito il trampolino di lancio da cui è iniziato il processo di inglobamento delle società senza Stato in quelle di questo dotate, ossia il colonialismo e il predominio del cosiddetto Occidente.
Note
[1] L’espressione “società primitive” sarebbe oggi tacciata di etnocentrismo e d’altra parte indica in maniera indifferenziata un insieme di forme di vita sociale assai diverse tra loro.
[2] Cattivo incontro, incidente.