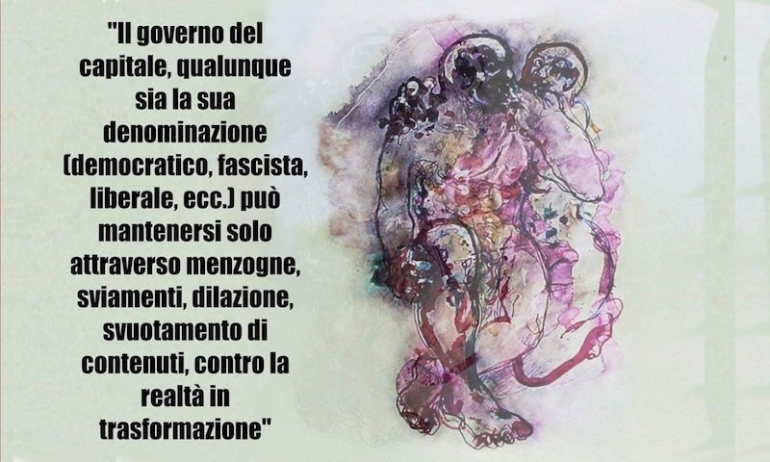Nei nostri tempi di continua precarizzazione del lavoro, delle finte “autonomie lavorative”, dei lavori senza contratto, dei “lavoretti”, della mancanza di sicurezza sul lavoro, ecc., sembra prioritario fare chiarezza sulle cause delle modalità remunerative che tendono a cancellare il significato di salario, erroneamente identificato nella sola busta paga. Le ultime generazioni non conoscono a volte neppure l’uso di questo termine, al massimo si parla di stipendio, quando devono ricevere un pagamento per prestazioni effettuate.
Anche la comunicazione mediatica favorisce l’obliterazione concettuale del lavoro salariato usando prevalentemente le parole come “occupazione” o “disoccupazione” legate ad una ineluttabile fase di crisi economica, di cui non si menziona né l’origine né le dinamiche di una sua possibile risoluzione.
Riaffrontare i temi legati al salario ripropone quindi una necessaria riflessione critica sui temi sociali legati all’attualità sì dei processi inflattivi, dei fenomeni ambientali e migratori, delle innovazioni tecnologiche, ecc., ma soprattutto delle relazioni sociali che fanno capo alle “diseguaglianze” e alle “povertà assolute e relative”, su cui ormai si organizzano analisi e dibattiti diventati di moda.
Per orientarsi pubblichiamo la presentazione del libro di Gianfranco Pala “Propriamente salario sociale di classe. Critica delle mistificazioni del valore della forza-lavoro” edito da La Città del Sole che sarà presentato venerdì 6 marzo 2020 alle ore 18.30 presso la Libreria Fahrenheit 451 Piazza Campo de’ Fiori 44 - Roma da Carla Filosa, Presidente dell’Università popolare A. Gramsci, che ne ha scritto l’introduzione che proponiamo ai nostri lettori

Il “Salario sociale – La definizione di classe del valore della forza-lavoro” [ed. Laboratorio politico, la Città del Sole, Napoli 1995] focalizzava in tempi diversi dall’oggi – circa 21 anni fa – quella che comunemente si intende per remunerazione o compenso per tutto il tempo di un lavoro svolto. L’ampliamento conoscitivo della miseria di questo “senso comune” illusorio, in quanto indotto dalla falsificazione dominante, dettava allora come adesso la necessità di fornire la strumentazione concettuale storicamente corretta e completa, cioè insita nelle cose, necessaria alla formazione di una coscienza di classe che sia rimasta ancora restìa all’omologazione dell’esistente. Con l’obiettivo di rivolgersi a tutti, allora come adesso, deve essere chiaro che si è consapevoli di non poter sfuggire alla contraddizione reale di ricorrere alla parte pensante di quei tutti, in una fase in cui il pensiero è stato delegittimato ad affrontare i problemi della vita, a favore invece di fattori regressivi quali emotività, irrazionalità, fideismi, ecc. Tuttavia è una necessità collettiva l’impegno a riabilitare quella parte razionale che non in tutti ha avuto la possibilità di formarsi nella concretezza della propria vita, e che ci spinge a creare quelle condizioni mancate per maturare l’interesse a capire, quale priorità, le modalità di lotta attuabile per conquistare la sopravvivenza o se possibile il benessere, costantemente minacciati da un sistema nemico così velocemente proteiforme.
Ogni forma di cultura, in effetti, è destinata a penetrare nelle menti per attivarne prima possibile i comportamenti conseguenti. Va precisato, però, che il potenziale interesse o attrazione che permetta di agire in forme efficaci rispetto al fine propostosi, non può aver nulla a che fare con le numerose facilitazioni di seduzione, volte invece a soddisfare l’utile delle opportunità politiche del momento. Il “parlare alla pancia”, come oggi si ama dire secondo una moda accattivante e per lo più di parte padronale, seppure capace di fascinazioni e illusioni per vincere qualche battaglia anche importante, non ha alcuna possibilità di incidere poi sui reali conflitti della storia, quali uniche cause dei mutamenti in cui siamo invece determinati a inserirci e presenziare. Questi ultimi hanno infatti altri obiettivi e processi ben più complessi, criptici e perciò sempre da scoprire e sostenere, se ancora aspiriamo a che le nostre lotte possano avere qualche probabilità di successo. Sempre rallentati pertanto dal fardello di questo ineluttabile limite storico-sociale, di interessare quindi soltanto coloro che dalle sconfitte hanno ormai imparato a lottare in modo più mirato allo scopo attraverso scelte consapevoli, e che possibilmente diventeranno esempio e oggetto di emulazione per altri, si è cercato di continuare la lotta teorica contro gli occultamenti e gli inganni di questo sistema sempre più distruttivo, ma inesorabilmente in via di estinzione.
Questa nuova edizione del “Salario Sociale di classe”- propriamente, SALARIO SOCIALE DI CLASSE: critica delle mistificazioni del valore della forza-lavoro - dunque, non vuole essere una banale ripetizione di concetti già espressi, ma invece una loro maggiore articolazione dovuta al confronto con la realtà odierna, che appare con svariati fraintendimenti spacciati per “cambiamento” – senz’altro dire – nel depauperamento delle masse, inevitabile e obbligato come un fato, calcolato però nelle secche dell’accumulazione in crisi irresolubile. In questa realtà mutevole di rapporti di forza e di leggi a loro sostegno, infatti, si affacciano chiaramente tendenze politiche ambigue, di difficile decrittazione come:
1) La pianificata vanificazione dei diritti sociali acquisiti nelle lotte dei secoli scorsi, e loro sostituzione con “nuovi” diritti individuali. Ad esempio il “diritto” al reddito di cittadinanza (o di “esistenza”! come proposto da G. Aznar più di una ventina di anni fa [cfr. Lavorare meno per lavorare tutti (1994), in condizioni consone al cosiddetto “capitalismo cognitivo” in presenza di “decrescita”] dietro cui cancellare la dipendenza salariale e con essa il conflitto sociale strutturale. Questo permette di introdurre la riduzione all’elemosina di stato per mendicanti-lavoratori, costretti a qualunque dequalificazione pur di riuscire a percepire un sostegno minimo per sopravvivere.
2) Allargamento senza limiti dell’esercito di riserva sia nell’organizzazione del lavoro (ad es. “selettività delle assunzioni e dei licenziamenti” ormai pienamente discrezionali), sia nell’uso senza regole della forza-lavoro immigrata già predisposta a qualunque ricatto o sopruso. Quest’ultima, inoltre, va a incrementare le statistiche delle cosiddette “diseguaglianze sociali” di generica e sociologica discettazione, senza cioè che si risalga mai alle cause capitalistiche della loro determinazione. Tale migrazione umana, che oggettivamente sta modificando le condizioni dell’esercito di riserva internazionale e nazionale nell’ambito di un sistema mondiale, testimonia l’ulteriore aumento del divario tra paesi – o meglio capitali – dominanti e da dominare, e questi ultimi, poi, gestiti dall’imperialismo in modi altamente differenziati (attraverso banche, debiti pubblici, investimenti dietro ricatto, azioni belliche, terrorismo pilotato, ecc.).
3) La programmazione di classe della produttività, non da intendere però come generico aumento di produzione sociale di merci per l’uso, ma come intensificazione dei ritmi e riduzioni delle porosità nei tempi di lavoro per gli occupati, dei quali si intensifica l’abuso del loro consumo vitale. La contemporanea riduzione dei costi di produzione, realizzata attraverso i continui licenziamenti individuali e di massa, costituisce la spettrale alternativa all’imposto consenso allo sfruttamento.
Riguardo al punto 2), cioè all’estensione dell’esercito di riserva, è necessario soffermarsi su un ultimo ritrovato dei nostri tempi quale peculiarità di questa fase storica: la migrazione umana di persone in fuga da aree geografiche in cui la guerra dei capitali, presente o passata ma comunque sempre in vista della loro spartizione profittevole o strategica, impedisce la vita. La scala dell’accumulazione capitalistica non può sopportare confini geografici o storici definiti una volta per tutte. Ciò significa che la forma transnazionale del capitale è in grado di realizzare continuamente non solo le stesse unità produttive su latitudini diversificate e più opportune, con costi produttivi favorevoli o “gabbie salariali” di fatto confrontabili solo su visualizzazione planetaria, ma anche mediante l’“autonomo” trasferimento della forza-lavoro quale “effetto collaterale”.
Non importa dove, il capitale nella sua costante estensione per esistere deve trovare o forgiare una domanda di forza-lavoro perennemente impoverita, umiliata e obbediente da utilizzare con profitto. La permanenza nella necessità del bisogno viene poi alimentata da strutture laiche o religiose caritatevoli che soccorrono, sempre però entro un’emergenza resa inestinguibile e al contempo da mantenere insanabile. Sul piano politico questo stesso meccanismo si attua prevalentemente con l’uso del debito pubblico imposto agli stati capitalistici più deboli, in modo da esercitare un drenaggio di ricchezza da far affluire alle centrali del credito internazionale. La mediazione è effettuata dalla “governabilità” degli apparati statali, che usano o abusano di leggi in funzione dell’erosione insensibilmente lenta ma efficace dei salari diretti, indiretti e differiti, con il contemporaneo effetto di gestire la prevenzione o repressione degli eventuali dissensi.
La domanda lavorativa non può però eccedere le esigenze dei capitali che si servono di una popolazione costantemente a disposizione e che pertanto deve essere numericamente eccedente, superflua. Questa sovrapopolazione, viene prodotta dalle stesse cause che determinano l’ingrandimento dei capitali, essendo uno dei requisiti d’esistenza del modo di produzione in questione che, come l’avesse allevato a proprie spese, può servirsi di un esercito lavorativo a qualunque condizione. Queste masse soddisfano l’aumento di capitali addizionali in costante formazione e vengono reclutate e riprodotte proprio dalle oscillazioni produttive cicliche, consistenti in alta produttività, crisi e stagnazione. In questo continuo mutamento la sovrappopolazione può essere occupata, occupata parzialmente o in forme intermittenti, inoccupata sulla base dell’innalzamento della domanda produttiva, oppure dispersa nelle varie forme pauperistiche. Un eventuale maggiore investimento in capitale variabile poi, può significare un maggiore sfruttamento in estensione o in intensità della forza-lavoro, sostituendola mediante dequalificazione, ringiovanimento, assunzione di altri stranieri, ecc. L’accumulazione si accresce e contemporaneamente si dividono i lavoratori inducendo una guerra tra poveri e impoveriti nelle differenze etniche, razziali, religiose, linguistiche, di costumi, ecc. È in questo equilibrio contraddittorio di incremento di produttività e inoccupazione che l’accumulazione capitalistica si duplica dialetticamente in accumulazione di miseria sociale, oggi estesa a livello mondiale in base a leggi che somigliano a quelle naturali, ma che invece, essendo storiche, sono transeunti e pertanto destinate ad essere superate o travolte.
La prospettiva che si delinea è quella di far perdere a tutti il controllo delle condizioni della propria esistenza ovvero dell’unica dignità possibile, nella condizione di dipendenza totale, invece, dalle vicende periodiche dei cicli produttivi. Si ripropone oggi un meccanismo già noto nell’800, quello dello sfruttamento oltre ogni limite di quella chiamata all’epoca la popolazione nomade. Importatrice di malattie anche mortali, questa quota lavorativa vagante era sfruttata due volte: sul lavoro e come inquilini degli appaltatori, oppure poteva alloggiare in capanne fatiscenti ove ogni norma igienica veniva ignorata. Oggi sono state riprodotte queste stesse miserevoli condizioni di accampati, per tanti immigrati schiavizzati dal caporalato dei nostri tempi “civili”, e sono sotto i nostri occhi quale differenza dal nostro pur precario benessere, ma soprattutto quale ipotetica minaccia costante del declassamento delle giovani generazioni presenti e future, autoctone o miste.
Un continuo martellamento multimediale fa poi leva su sentimenti umanitari e inclusivi o, al contrario, su difese del privilegio, dei confini in senso esclusivo, sull’allontanamento o eliminazione dell’altro o diverso quale arcaica minaccia sempre riesumabile. Non si fuoriesce, cioè, dal piano moralistico di fatto concertato con quello politico dell’innalzamento dei muri e dei fili spinati, a barriera contro l’“invasione” dei derelitti. Il diritto non solo positivo, la legge scritta, ma quello umano, non scritto, viene impugnato o eluso in un conflitto ideologico per lo più funzionale a mire elettoralistiche, e che purtroppo nulla mostra della realtà materiale, su cui si sta scrivendo una pagina di storia di eccidio umano senza mai responsabili da accertare. Assassini sono infatti riconosciuti il mare, il freddo, la stanchezza, la malattia, la fame, o altre astrazioni senza mandanti. L’occultamento di un sistema mondiale – non quello sedicente “globalizzato” inteso come più o meno equamente integrato sul piano economico, ma quello capitalistico, che funziona solo in quanto ignora l’umano, a meno che non sia venduto per la sua capacità lavorativa in modo profittevole, ovvero sfruttabile, ovvero in parte gratuitamente appropriabile – diventa l’arcano da riportare alla luce della consapevolezza collettiva.
I numeri reali dei migranti nel nostro continente risultano notevolmente inferiori a quelli nel continente asiatico, americano e africano. L’esodo è mondiale (non si dimentichi il muro tra Usa e Messico dove i morti accertati si contano a migliaia e quelli non accertabili sono forse anche più numerosi) e costituisce un aumento della sovrappopolazione relativa, non in quanto fisiologia del sistema socio-economico, ma in quanto eccezionale esproprio di risorse anche lavorative nei paesi dominati dell’imperialismo vigente, dove l’asservimento alla condizione di lavoro latente, od anche fluttuante, soddisfa solo i bisogni immediati della riproduzione di capitale presunta eterna. Automaticamente gettati nel pauperismo (oggi si chiamano i poveri al di sotto della soglia di povertà, anch’essa variabile in base a paesi e criteri regionali) come condizione normalizzabile, al pari della morte per qualunque causa, questi disgraziati alla ricerca della sopravvivenza nel II millennio sembrano apparire, ad una sinistra imbelle e scriteriata, un’ultima occasione per rinvigorire nelle lotte le classi subalterne svenate dalle continue sconfitte di classe. Siffatta possibilità reale si lega però all’uso che se ne farà della loro futura utilizzazione quale forza-lavoro, per ora solo in funzione di un ipotizzabile abbassamento salariale localmente esistente. Effetto del continuo saccheggio imperialistico, questi sopravvissuti alle tragedie che ne hanno minacciato l’esistenza sono – per il sistema – solo potenziale lavoro-senza-condizioni, e pertanto preziosi come una promessa di pluslavoro inesauribile o sottosalari normalizzati. Culturalmente sradicati e oggettivamente mobili e flessibili, rappresentano anche il pregio di eliminare a prescindere la potenziale intrinseca conflittualità politica, favorendo con la loro sola esistenza la condizione per il deprezzamento continuo – seppure a macchia di leopardo – della forza-lavoro in genere, operato da un mercato mondiale sempre volto al peggioramento medio delle condizioni di vita dell’intera classe creatrice di valore.
In questo testo dunque si troverà un’analisi rigorosa basata sull’unica fonte, quella di K. Marx, perché in grado di individuare correttamente ogni aspetto del processo capitalistico, in particolare qui per quanto attiene alla specificità del lavoro salariato e quindi del salario come forma di classe, non giàindividuale. A tale proposito è bene rammentare però le definizioni di salario che diffusamente vengono a inondare dizionari, testi universitari e talk show vari, insistendo su fatti empirici che comportano la cancellazione conoscitiva della specificità capitalistica di questo sfruttamento lavorativo: unico obiettivo, invece, della gestione produttiva del sistema. Eliminare concettualmente termini devianti dalla rappresentazione di una realtà – sì volutamente invisibile, ma inesorabilmente operante e dominante sulla resa incondizionata di chi dipende dal mercato del lavoro (occupati o meno) –, significa fare un primo passo verso potenziali azioni in grado di riscatto e forse pure di rovesciamento dei rapporti di forza. Riconquistare una capacità difensiva, solidificata dalla conoscenza dei problemi da affrontare è l’unica dignità possibile, dunque ancora reale, un’utopia concreta in questa fase di crisi capitalistica, che viene riversata come sempre sulla forza-lavoro. Questa, inoltre, è tendenzialmente destinata a diminuire nelle aree a capitalismo dominante, perché continuamente smistata nelle aree a minor costo salariale, e programmaticamente sostituita da macchine in forza al capitale. Ciò significa che alla disgregazione e precarizzazione lavorativa della classe si aggiunge la dispersione riflessiva e organizzativa cui è forzatamente soggetta, e che pertanto avrebbe bisogno del massimo sforzo di strumentazione e ricomposizione possibile. Per quanto attiene infine alla cosiddetta “robotizzazione o fine del lavoro, tematica che qui non può trovare spazio sufficiente all’esposizione articolata dei problemi annessi, possiamo però dire che è sempre l’uso capitalistico delle macchine a scacciare lavoro umano, e non l’avanzamento tecnologo in sé a determinare i licenziamenti attuali e futuri.
È necessario capire a questo punto che il termine capitale – quando non si intende come singolo – si riferisce ad un’astrazione, un concetto entro cui si racchiude tutta una realtà storica trascorsa e presente, complessa quindi, relativa alla trasformazione della proprietà privata, ma di cui si è individuato un criterio di comprensione che ne segue lo svolgimento, lo sviluppo e le future tendenze. Il mutamento continuo di questa realtà storica mostra l’avvicendarsi di una produzione materiale di merci finalizzata non alla semplice produzione sociale di beni di consumo da scambiare, ma all’arricchimento privatizzato basato sull’aumento di un plusvalore interno alla merce, creato dal pluslavoro o quota di lavoro non pagato, funzionale anche all’aumento della quantità e varietà dei consumi. Questa merce specificamente realizzata entro il modo di produzione capitalistico è cioè una parte costitutiva aliquota del capitale, e si scambia come suo prodotto, secondo oscillazioni al di sopra e al di sotto del loro valore individuale in base ad un valore di mercato in continua espansione. La merce singola, poi, appare come parte del prodotto totale del capitale, come parte aliquota della massa di merci in cui si riproduce costantemente il valore del capitale anticipato e a cui, mediante il lavoro erogato, si aggiunge il plusvalore.
L’incarnazione di quest’ultimo è data appunto dal pluslavoro, o lavoro superfluo, in quanto eccedente le necessità di ricostituzione della forza-lavoro che l’ha prodotto, e si nasconde dentro la forma del salario, rimanendo sì invisibile ma operante [1], nella sua forma di denaro quale “forma trasformata del suo proprio lavoro futuro o di quello di altri lavoratori” (K. Marx)
Innanzi tutto bisogna demistificare il salario quale “prezzo del lavoro”, nella elitaria distinzione che serve a identificare uno status sociale: “salario” per operai; “paga” per braccianti; “stipendio” per impiegati; “onorario” per professionisti; “salario d’imprenditore”, si dice, da non confondere con profitto. In queste comuni denominazioni infatti non è possibile rintracciare che la remunerazione non riguarda il lavoro svolto in quanto risultato, mentre invece si paga la sola forza-lavoro venduta. Soprattutto, non risulta quanto di siffatta forza-lavoro sia pagato, relativamente a quanto non sia invece gratuitamente appropriato, di un orario lavorativo cioè apparentemente tutto remunerato, ma di cui in realtà una quota – sempre misteriosa – il datore di lavoro silenziosamente si impadronisce. Il denaro guadagnato col lavoro poi è sempre segno di un lavoro passato, da convertire a sua volta con mezzi di sussistenza più o meno nell’immediato, quindi dilegua nella forma di denaro per trasformarsi nel consumo necessario alla ricostituzione della forza-lavoro. Questo denaro è improduttivo per il lavoratore. La vendita di sé, effettuata continuamente dalla forza-lavoro, invece, fornisce un valore di cui il capitale si appropria e che ingloba come capitale variabile, nella forma quindi produttiva per il capitalista.
Già avere questa cognizione può sgombrare il campo dall’affidarsi al credo liberista del “giusto salario” (di ispirazione medievale a proposito della “giusta mercede” sponsorizzata dal potere ecclesiastico), oppure a quello sociologico o umanitario di sinistra (in genere) secondo cui “il lavoro non è una merce” (Cfr. L. Gallino, 2007). Corretto concettualmente è infatti considerare il lavoro l’erogazione in atto o già realizzata della capacità di trasformazione della natura propria della forza-lavoro, intesa come energia, forza muscolare, abilità, intelligenza, cultura, ecc. specifica dell’essere umano, che pertanto porta a considerare la forza-lavoro inseparabile dalla persona che ne è portatrice. Moralmente, o peggio ideologicamente, non si riconosce la distinzione – operata invece nella ordinaria relazione capitalistica – tra forza-lavoro coartatamente mercificata, e mantenuta in vita solo in quanto tale, e persona, non suscettibile di essere venduta se non nelle forme della schiavitù passata e presente. La continua sorpresa per la “fatalità”, poi, per cui il salario è talvolta storicamente costretto a scendere ai livelli di fame, è invece un’ulteriore mistificazione del normale funzionamento di questo sistema. Questo infatti è volto forzatamente a produrre beni di consumo, ma unicamente per carpire quella quantità di pluslavoro in modo gratuito, da cui proviene l’origine sociale e l’incremento dei profitti di capitali sempre contendenti a livello mondiale. Siffatto lavoro superfluo, condizione di esistenza di quello necessario alla ricostituzione della forza-lavoro, è poi più facile estorcerlo se i lavoratori sono assunti individualmente o attraverso contrattazioni collettive, i cui arbitrati siano però pacificamente determinati e concilianti. Alcuni esempi possono essere pratiche istituzionali atte a determinare una stratificazione del mercato del lavoro che condiziona anche l’andamento salariale; informazioni asimmetriche tra lavoratori e imprenditori [Shapiro e Stiglitz, ‘84]; un sindacato monopolista per la gestione della disoccupazione involontaria e dell’imperfetta flessibilità salariale; ecc.
Le ultime leggi come quella detta di S. Valentino ‘84 (abrogazione dell’indicizzazione autonoma dei salari all’inflazione); il Protocollo d’intesa ‘93 (politica dei redditi e indicizzazione istituzionale dei salari all’inflazione); la legge Treu ‘97; Maroni / Biagi (introduzione dei contratti atipici); il Jobs Act ‘15, relative alla nuova regolamentazione del mercato della forza-lavoro in Italia hanno di fatto determinato la diminuzione delle assunzioni stabili, specie se a tempo indeterminato (Inps 2016). Di queste se ne era ottenuto un incremento nel 2015 solo in virtù dell’abbattimento integrale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per tre anni. Altresì, sono risultati in aumento i licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo, come pure i voucher, espediente anch’esso anglofono e neutro rispetto alla sua funzione di essere contromarca, biglietto o “buono” atto sostituire un potere d’acquisto a volte anche inferiore al suo valore esposto, per pagamento di prestazioni di lavoro accessorio, invece di far emergere quale meta dichiarata il lavoro nero esistente. Seppure i voucher fossero eliminati completamente (dopo il balletto della loro scomparsa e riapparizione sul mercato non solo occasionale del lavoro quasi sempre nero), l’inventiva padronale per pagare sottosalari non potrebbe mai arrestarsi, ferme restanti queste condizioni. Il fine occulto e sempre dissimulato interno a questo processo per tappe è sempre quello di indebolire l’efficacia contrattuale della forza-lavoro, costretta ad abbandonare ogni rivendicazione lavorativa pur di difendere un minimo salariale possibile per la propria sussistenza.
La diminuzione progressiva fino all’annullamento dei diritti sociali della forza-lavoro, nelle aree del mondo in cui lotte storiche ne avevano determinato la conquista, indicano l’obiettivo di riuscire a gestire liberamente un massimo di pluslavoro ottenibile solo mediante il ricatto del lavoro necessario reso precario o sempre annullabile, sulla base delle esigenze dei capitali mondiali stretti da una crisi insolubile di accumulazione. In siffatti meccanismi dispotici viene quindi a cancellarsi la differenza – basilare per questo sistema – tra il corpo del lavoratore, quale vero oggetto della locazione di energie umane per un lasso di tempo, e la sua persona. Quest’ultima non ha infatti qui alcun valore economico mentre le prime, o forze-lavoro in genere, solo se vendute, acquisiscono valore consumabile e danneggiabile in forza ai capitali, in quanto capitale fisso. Anche nella fase terminale del loro rilascio il capitale deve continuare ad assicurarsi un assoggettamento pragmatico, e solidificato dall’abitudine, nell’accettazione incondizionata del deterioramento fisico conseguito in modo irreversibile, come pure della probabile incompleta restituzione del salario differito nella forma pensionistica o della liquidazione. La subordinazione lavorativa deve essere quindi preordinata già nell’ingresso incerto al mercato del lavoro e per lo più pilotata in base alla disponibilità al consenso, mantenuta durante l’attività conseguita con mansionari, orari e rischi ormai indeterminati, con l’esito lavorativo discrezionale e sempre soggetto a licenziamento improvviso e senza appello. Le disquisizioni sociologiche o religiose sul concetto di “persona” così funzionalmente dimidiata e disumanizzata non mutano la realtà, che intenti ideologici di dominio cercano continuamente di nascondere, mitigare, distrarre, fraintendere, mistificare, attraverso il concerto di un’industria comunicativa quasi completamente asservita ai poteri dispotici, cosiddetti “forti” come inutile pleonasmo.
In quanto poi alla elusione coscienziale sull’evidenza materiale del lavoro dipendente, si è tentato di tutto. “A progetto”, “partite Iva”, “lavoratori autonomi”, ecc. sono stati numerosi gli sforzi di denominazioni nuoviste, per dividere “tecnicamente” la forza-lavoro e negare l’immagine reale della dipendenza dei nullatenenti dal potere privato dell’investimento produttivo. La manipolazione massima si è però raggiunta nella definizione di salario in quanto “partecipazione agli utili” o “partecipazione” senz’altra specificità, ma con allusione neocorporativa di prono consenso sociale al sistema nel suo complesso. Tale coinvolgente interpretazione edita nientemeno già due secoli fa entro il potere dello stato vaticano, punta alla vantaggiosa scomparsa del concetto di classe di chi detiene i capitali e di chi, essendone stato privato, è costretto a dipenderne per vivere. Viene così ideologicamente annullato l’antagonismo strutturale, fondato sullo sfruttamento quale cardine della relazionalità ineguale dell’apparente libero scambio tra eguali sul mercato del capitale. Partecipare, infatti, prevede concettualmente eguaglianza decisionale e di ripartizione della ricchezza conseguita. “Salario” è invece proprio il travestimento della diseguaglianza di una classe proprietaria che rafforza il proprio potere sulla spoliazione programmatica di masse rese bisognose per essere destinate a creare ricchezza per altri, e la parziale remunerazione di queste masse rimane necessaria alla costante minima ricostituzione delle forze e della loro riproduzione. L’essenza – o mistero – dell’origine dei profitti risiede dunque nel lavoro erogato e non pagato, quale sopruso sancito dall’abitudine storicizzata di governi spesi all’assoggettamento permanente di lavoro altrui, di cui si è finemente studiato per ottenerne l’oblio. La “partecipazione” è dunque un eccellente mezzo di perdita di memoria di questo passato invisibile ma tuttora attivo nel presente, edulcorato da ideologie al potere autodefinitesi “fine delle ideologie”, democratiche quel tanto che basta a capovolgerne il vero significato, mezzo cosmetico di questa continua violenza che appare solo come eccezione (si pensi solo alle infinite vittime dell’amianto, ai morti bruciati della Tyssen-Krupp, alla Snia di Taranto che offre l’alternativa tra la morte per fame o per cancro, ecc.), ma mai come norma.
Tutta una terminologia anglofona dominante si è resa complementare ad impedire comprensione e riconoscimento della realtà, sempre da cancellare nelle masse da sopire. Il disoccupato viene chiamato dagli economisti “nuovisti”: “job finding” al posto di “cercatore di lavoro, mansione, attività da svolgere”; “job separations” sta per maggiore precarizzazione (ridurre i costi di assunzione più di quelli per licenziamento); “two-tier - reforms” invece per riforme a due livelli (il quadro giuridico resta immutato mentre le forme contrattuali sono libere); riforme incomplete si hanno poi quando viene accentuato il: “trade off”, o alternativa tra equivalenti all’interno dello scambio; “life-long learning” sta a sostituire la formazione professionale per tutta la vita lavorativa:, ecc. Ultima moda – al momento – è esaltare i vantaggi dello “smart working”, in cui si racchiude ogni aspetto della subordinazione lavorativa. Possibilità di ordini a distanza, luogo e tempo lavorativo indefiniti e variabili, controllo tecnologico anche da remoto, utilizzo della forza-lavoro secondo necessità, remunerazione a risultato ottenuto. Una prima riflessione porta a considerare l’isolamento lavorativo su cui è stato concepito; questo impedisce ogni forma di consapevolezza o controllo del proprio status, mansione o orario lavorativo, in modo da realizzare una delle forme più sofisticate di mascheratura del cottimo. Quest’ultimo, ma senza nominarlo, altro non è che il lavoro a tempo – ma formalmente senza tempo – calcolabile per intensità e qualità di tempo necessario all’espletamento di un determinato lavoro su uno standard ristretto, oltre il quale la remissione è tutta del lavoratore. Il “risultato”, “pezzo” o “rendimento” consente infatti di ottenere la superfluità della vecchia sorveglianza sul lavoro, come pure di obliterare il percorso lavorativo (tempo) – ossia l’aumento dei ritmi di lavoro (intensità) e la saturazione dei tempi morti (condensazione) – con i possibili impedimenti e difficoltà impreviste. Si punta infine solo sulla remunerazione prefissata, che in genere rappresenta una decurtazione salariale vantaggiosa per il datore di lavoro, sempre in grado di prefissare su un piano alto di esecuzione temporale il salario minimo. Sull’obiettivo risultato, dunque, viene a cancellarsi la funzione fondamentale dell’attività vivente della forza-lavoro (valore d’uso), artatamente sostituita dalla oggettività morta del rendimento ultimato immediatamente appropriabile. Fa parte di questo ritrovato anche l’altro sventagliamento contrattuale che prevede il “salario progressivo o a incentivo”, costituito da una quota fissata a tempo (minima) e un’altra variabile a rendimento, che stimoli perciò all’autosfruttamento senza risparmio di energie, pur di raggiungere un livello di reddito (salario reale) adeguato al costo della vita costantemente in aumento. L’invisibilità sociale e quindi l’efficacia funzionale di siffatti meccanismi risiede nel coinvolgimento individuale in cui ci si percepisce apparentemente liberi e autonomi, e la cui falsa autodeterminazione tende a favorire invece la concorrenza tra lavoratori. Il dispositivo così ottenuto produce perciò l’effetto reale di abbassare il restante livello medio salariale, per inseguire l’aumento di pochi salari individuali al di sopra di quel medio stesso. Il vantaggio per l’incremento dei profitti viene raggiunto proprio mediante il comportamento stesso di coloro che, se ne avessero maturato coscienza, ne sarebbero stati gli antagonisti.
Tutta l’economia volgare, tra cui è da annoverare anche quella moderna o marginalistica e successive, considera invece l’economia capitalistica come una semplice produzione di merci il cui scopo è il consumo di beni utili, secondo un “processo – che – appare semplice e naturale, cioè – che – possiede la naturalezza del razionalismo superficiale” [K.Marx, ]. Tale definizione è fondamentale coglierla appieno in quanto l’identificazione della specificità di un sistema fornisce la sostanza del funzionamento in questione, anche se aspetti salienti possano somigliare anche ad altri sistemi economici. La specificità capitalistica è quella della valorizzazione per il solo capitale. Il denaro investito nelle attività produttive attraverso la produzione di merci e la loro vendita deve risultare aumentato, e il più possibile. E questo denaro, che non va più considerato come semplice mezzo di circolazione, ma come capitale, proprio per questa sua funzione di accrescimento determinato, viene valorizzato solo dal lavoro altrui salariato (quale erogazione della forza-lavoro, o merce venduta), lavoro che crea neovalore parzialmente gratis. Nell’immanenza della produzione di merci, dunque, si colloca il rapporto bilaterale tra capitalista e lavoratore salariato, fondato sul carattere sociale della produzione. In questo rapporto, dunque, si situa la contraddizione antagonistica reale, non l’odio o l’invidia di classe – come ideologicamente è continuamente falsata da canali multimediali – cioè trasposta su sentimenti, ideologie o moralismi di una supposta soggettività appositamente degradata. La valorizzazione – prodotta certo dall’“istinto all’arricchimento” cui Marx fa cenno – e la giornata lavorativa complessiva sono oggettivamente, materialmente espressione di realtà reciprocamente antagonistiche: quanto più si ingrandisce la prima tanto più si allunga la seconda in termini di tempo, intensità e/o condensazione.
Note
[1] Si utilizza rigorosamente il termine “operare” distinto da “agire”, nell’accezione stabilita daBaruch Spinoza [Ethica more geometrico demonstrata (1677)]. Nel primo termine ci si riferisce come a necessità, alla determinazione da altro, in senso coatto, mentre nel secondo si indica qualcosa di adeguato alle proprie azioni, in termini di libertà, provenendo unicamente dalla propria natura.