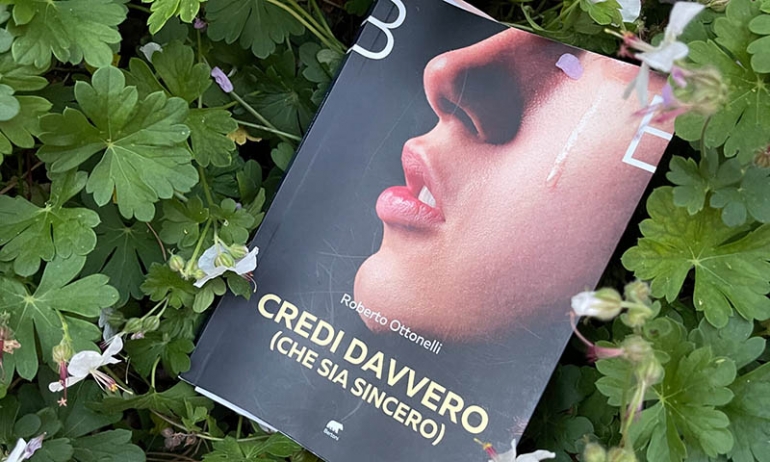L’approccio giornalistico alla violenza di genere è quantomeno sbagliato: infatti, troppo spesso si parla delle vittime come mere ed eterne condannate alla servitù volontaria quando, purtroppo in realtà, il loro altrettanto frequente, estremo sacrificio testimonia quanto la ribellione al potere possa giungere al prezzo della vita stessa.
Dall’altra parte, si può facilmente intuire la difficoltà nel raccontare le vicende di cronaca nera senza cadere nel macabro infotainment tanto dettagliatamente scabroso quanto funzionalmente inutile, e come sia ancor più complicato produrre un intero romanzo corale a voci contrapposte sul tema della violenza che, prima di palesarsi, è sempre subdola, sibillina nei suoi segnali e, proprio per questo, estremamente ardua da identificare sin dalle sue iniziali, inarrestabili fasi.
Se scrivere può e dovrebbe essere una missione, è quasi fisiologico che, tra l’autore, il suo articolo o il suo libro e il pubblico dei lettori si crei uno strano e curioso rapporto; potremmo indicarlo persino come una triangolazione particolare, che porta il narratore a guardare la sua pubblicazione dall’esterno, in guisa di creatura da osservare al massimo con fare protettivo, e i fruitori a esserne tanto immersi da coinvolgersi attivamente.
È questo il caso del libro Credi davvero (che sia sincero), scritto da Roberto Ottonelli e pubblicato dalla casa editrice Bertoni [1], il cui titolo, più che ispirarsi a uno spettacolo live di Vasco Rossi, sembra attingere da un mondo crudele coi suoi figli pronti a cambiare rotta dopo aver preso consapevolezza delle sue infime storture, mentre grazia inspiegabilmente i reificatori, i mercanti di vita e morte altrui i quali, lungi dalla pelosa compassione per chi sbaglia, chi cade, difficilmente si redimeranno senza un rigido, duraturo e tortuoso percorso di autoconsapevolezza e destrutturazione di ogni loro deviante percezione degli altri e, con loro, delle relazioni sociali.
Infatti, come scritto dallo stesso autore Ottonelli nei ringraziamenti finali per la sua seconda opera pubblicata, “l’idea è di parlare, condividere, raggiungere persone che non siano più disposte a girarsi dall’altra parte, a fingere che non esista una realtà che riguarda tutti”.
Ed è anche grazie a questo intento che in Martina e Antonio, protagonisti alla pari nella narrazione, si può riconoscere chiunque di noi, così come nell’iniziale citazione del terzo capitolo del “Qoelet” che evidenzia il “(…) tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. (…) Un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace” [2].
Pagina dopo pagina, si delinea chiaramente come il tempo di guerra sia quello dell’abbattimento del potere che crea soprusi, e di lotta anche legale per il ripristino di una giustizia violata dal punto di vista personale e sociale; perché, se ognuno di noi può immedesimarsi nei protagonisti e, soprattutto, nella vittima, allo stesso modo questo emotivo processo di empatizzazione può e deve richiamare anche gli indifferenti, ossia i gramsciani pesi morti della storia che ignorano gli equilibri di cristallo regolatori di relazioni già di per sé sbilanciate, come quelle di genere, rendendole più ipocritamente fittizie o, ancor più colpevolmente, celandole dietro discorsi tossici incentrati sullo spietato individualismo delle scelte sbagliate da pagare in base a una sorta di loro, personale e morale legge del taglione.
Invece, la penna dell’autore aiuta tutti, noncuranti compresi, a calarsi nella escalation della quotidianità di due persone considerabili normali, come la giovane Martina, solare, espansiva, piena di voglia di vivere, di forza di volontà nello svolgere più lavori contemporaneamente, di spirito di iniziativa e di sacrificio nel mantenere la propria autonomia e le proprie solide relazioni sociali.
Perché, secondo le parole che Ottonelli le affida con cura e delicatezza, Martina sa e dice che “la vita non regala niente”.
Già solo partendo da quest’iniziale affermazione, si può prontamente sradicare una delle prime erronee convinzioni della retorica giornalistica che descrive le vittime come soggetti sempre e solo deboli nonostante, nella fattualità, proprio queste siano prescelte dai manipolatori perché incarnano il loro esatto contrario: sono indipendenti, autonome, perfettamente integrate nella comunità e, anche nel caso in cui i carnefici fossero arrivati al punto tale da diventarne i carcerieri sottrattori di ogni possibile libertà, le loro prede mantengono sempre quello stesso potenziale che i primi non avranno mai e che, proprio per questo, diventa motivo della loro invincibile invidia, dei loro incontrollabili moti d’ira e, se non li si arresta prima, persino movente dei loro efferati crimini.
Antonio, il protagonista maschile prima ancora che antagonista, in una delicata ricostruzione che l’autore opera come fosse un chirurgo del male, in un mondo al dritto sembrerebbe una marionetta in balìa del passato che ne condiziona il presente fino a inondarlo, con la sua perenne difficoltà nel capire perché le responsabilità familiari siano ricadute proprio su di lui il quale, per sua stessa ammissione, “(…) non ne [ha] le forze né le capacità”.
La mancanza di vita sociale e l’isolamento forzato al quale Antonio è costretto dal narcisismo familiare, lo portano alla nemmeno tanto convinta ricerca di stimoli “(…) per non morire dentro”.
La realtà delle storie di ordinaria follia ci racconta dello stress che, creando un cortocircuito psico-fisico definito burnout, se sublimato diventa come il sonno della ragione, finendo per generare dei mostri.
Quando due personalità diametralmente opposte si incontrano, possono generarsi meraviglie del pensiero e dell’azione; ma, se a farlo sono una inconsapevole quanto potenziale perché appetibile vittima e un manipolatore dai tratti patologici, può solo cominciare l’escalation della violenza, con tutto il suo corollario – o pattern – di fasi codificate a livello psicoterapeutico.
Così, come scritto in Credi davvero (che sia sincero), già a una prima, superficiale conoscenza, il prossimo oppressore metterà in atto un tecnica di mirroring attraverso cui la vittima possa erroneamente pensare di specchiarsi in un’estrema e quasi simbiotica sintonia di pensieri e, talvolta, di azioni, gusti personali, scelte ed esperienze di vita, abbassando la soglia della guardia che impedisce di comprendere subito quanto queste personalità disturbate non siano davvero empatiche, bensì intenzionate a spegnere le vittime – come effettivamente loro si sentono e sono – allo scopo di manipolarle meglio, finendo per privarle delle doti per le quali prima le lusingavano e che, poco tempo dopo, emergono pesanti come macigni sulla mediocrità dei carnefici in quanto inaccettabili minacce alla loro esclusiva e malata volontà di possesso.
A dimostrazione di ciò, Antonio, con particolare riferimento a una sua relazione passata, non capisce e tanto meno accetta di essere stato liquidato “come una cosa vecchia, buttata nel cassonetto della spazzatura”, non perché ferito e necessitante del fisiologico tempo di ripresa da una delusione sentimentale, ma perché incapace di gestire in maniera non violenta i suoi scatti di rabbia, troppo preso com’è dalla sua recita nel ruolo dell’eterna vittima di tutto e di tutti: della famiglia, del lavoro, dell’ambiente sociale circostante, del fato e delle donne.
Le retoriche sull’unica e sola responsabilità individuale sono pane per chi pensa sia possibile esercitare il potere magico della lettura nella mente altrui quando, già dai primi appuntamenti, una persona che sembra tutt’altro che ansiosa – e che si bea della riuscita della sua recita – nasconde un’anima nera angosciosa, insultante perché piena di dubbi infondati, insinuazioni e mattoncini di creta di un finto sé.
“Non farei mai qualcosa che tu non vuoi”, spergiura lui già a inizio frequentazione intenzionato, oltre ogni ragionevole dubbio, a preservare la sua maschera di accettabilità sociale a mo’ di alibi verso il palesarsi della sua stessa violenza.
Risulta infatti impossibile capire cosa scatti nella mente di un adulteratore dell’animo umano tanto da incanalare le sue azioni in vere e proprie fasi, prescindendo dall’unica, grande e terribile verità che scandisce il precipitare del tempo verso la vessazione: quando comincia a profilarsi il love bombing o “luna di miele” del ciclo della violenza, ovvero il bombardamento di finte attenzioni amorose verso la vittima, ci si è purtroppo già calati nella premeditazione del male.
A cadere nella maliarda trappola del violento, quella basata sulla sì nobile intuizione di un’atavica e radicata paura “(…) di non essere all’altezza, di essere ferito”, non sono crocerossine pseudo-dipendenti affettive descritte sulle pagine di qualche rivista patinata che spaccia il mondo femminile per unidimensionale business di balocchi e profumi, bensì chiunque creda nella sincerità di veri potenziali criminali dal profilo psico-patologico non ignorabile.
Sono loro, i sofisticatori delle relazioni sentimentali, a dover essere analizzati nella sotterranea volontà di usare le persone, disponendone a proprio uso e consumo sia quando le riducono ad avventure fisiche di poco conto, sia, come nel narrato caso di Antonio, quando occupano gli spazi vitali delle loro succubi, come la casa e il tempo per qualsiasi cosa, dal lavoro a quello per la famiglia e gli amici, considerandole comunque prede sessuali da spersonalizzare.
Alla fine della fiera, l’aguzzino, proprio come il protagonista del libro, si discolpa autoconvincendosi della propria ricerca di una partner “(…) diversa dalle altre”, finalizzata alla mera dimostrazione da status della riuscita nella costruzione di una storia seria, solida e duratura, coronata dal matrimonio e dai figli ma, concretamente, rinchiusa entro categorie paternalistiche, mai superate, di appartenenza e riduzione della donna ad angelo del focolare, scaldaletto e sacco da pugni delle frustrazioni del padre padrone di turno.
I campanelli d’allarme non sono sovente colti perché facilmente sottovalutabili da chiunque non viva sul chi va là della paranoia nei rapporti interpersonali ma, riga dopo riga del libro Credi davvero (che sia sincero), si viene colti da un senso di insicurezza che, dopo un rapido indugio, si tramuta in disgusto verso Antonio il quale, nella sua perseverante copertura vittimistica, svaluta colei che considera una sua ex, – in realtà ragazza libera che lo aveva rifiutato intuendone il potenziale violento dopo un’insensata reazione fisica al suo diniego –, mentre comincia un nebuloso, insensato e serrato confronto proprio tra lei e la nuova conoscenza Martina, persona diversa come ognuno di noi rispetto agli altri ma colpevole di appartenere allo stesso genere e di essere caduta nella medesima trappola, per una mente confusa e disturbata come si dimostra rapidamente essere quella dell’uomo in questione.
Quest’ultimo è proprio colui che ripete a tutte le sue nuove sottoposte la stessa, ormai persino stantìa, versione preconfezionata da eterno perseguitato in grado di sviare da sé ogni responsabilità, sospetto e colpa, grazie alle sue infiocchettate motivazioni legate al voler “(…) essere sincero da subito”, “non voler nasconderti niente” e presentarsi “per quello che sono”.
Non arrendersi al male equivale anche al manifestare apertamente le intuizioni, così come fanno la madre, le amiche e qualche conoscente di Martina, funzionali ad arginare le tattiche manipolatorie in un rapporto che si rivelerà presto malato perché, se da un lato il disturbo ha già colonizzato la mente e l’operato del seviziatore, dall’altro condurrà la vittima al declino psicologico e, vista la somatizzazione del dolore, anche fisico.
Nonostante l’isolamento al quale via via Antonio la costringe, tanto da condizionarla in ogni pensiero, azione e persino inazione, le perplessità e le aperte contrarietà del suo intorno fanno breccia in Martina: rivelatrice la frase attribuitela dall’autore, secondo cui “tenere a una persona è anche dire quello che non fa piacere sentire”, così come la sua lucida e drammatica consapevolezza “(…) del vortice in cui sono entrata”, specchio del torbido cambiamento e della paura – che sente ma, come tutte le ignare vittime, non sa interpretare e indirizzare con esattezza –, e del tempo sempre più ristretto per lo svolgimento delle sue attività professionali e sociali, al punto tale da non stupirsi tanto dell’approfittamento materiale messo in atto dal nuovo fidanzato senza alcuna solida base di conoscenza reciproca, bensì della già nota capacità dell’amica Luna “(…) di guardarmi dentro”.
Tutto ciò succede perché Martina, come qualsiasi persona travolta dal male, viene interamente monopolizzata dal carnefice che raggiunge il suo intento manipolatorio quando riesce a farsi credere in ogni bugia, cominciando da quelle piccole o impercettibili come i gusti musicali, spacciandoli per propri come Antonio fa con Vasco Rossi che, però, piace solo a Martina e che lui finge di apprezzare perché l’abusatore dell’ingenua fiducia studia la vittima sin dentro l’intimità del suo ambiente – come fa il protagonista nella sua compulsiva ricerca di “indizi” nella casa della quale si è di fatto appropriato – per attingere informazioni che fingerà poi fossero in comune con quelli della “sua” lei.
L’invasione degli spazi e la sottile ma inesorabile sottrazione del tempo sono solo due degli innumerevoli aspetti di una tacita violenza facente leva sull’insinuazione di un sottile ma logorante senso di colpa nella vittima.
È così che, fra Martina e Antonio, cominciano i litigi per futili motivi, eterodiretti dall’atteggiamento di quest’ultimo, che, inconsapevolmente, la ragazza non mette in relazione con la sua ormai quasi perenne “(…) sensazione di inquietudine” e che Antonio sa però far dissolvere con una sapiente intermittenza di parole da copione, plateali gesti da nobiluomo d’altri tempi e una certa dose di maestria nel collante dell’intimità.
Antonio, invischiato in un legame malato col suo passato che ne condiziona ogni azione attuale e futura, finisce per creare una famiglia fittizia, opprimente e inquietante, valevole solo nella sua testa perché, concretamente, cresce in lui la rabbia per le occasioni di tradimento sprecate, brandite come vendetta nei confronti di una compagna della quale si dice innamorato ma che, in modo banale, incarna solo il tiro al bersaglio delle sue insicurezze sublimate, nel peggiore dei modi, con l’estrema possessività delle volgari illazioni, dei divieti imposti contro le normali libertà di vita di una persona che è e deve rimanere tale anche in coppia, così come in un qualsiasi costrutto sociale, e del totale controllo gestionale dei meccanismi di godimento o di negazione sessuale.
Nonché nella totale invasione e disposizione degli spazi della vittima, che diventano casa occupata dall’abusante il quale, imperterrito, continua a voler far credere alla “prescelta” di aver rivoluzionato la sua vita quando, in verità, lo fa più o meno consciamente per mantenere gli stessi devianti schemi del paradosso del lampione [3], per lui comodi al fine di rovesciare le esistenze degli altri verso le quali non nutre alcuna rispettosa ed empatica considerazione – per incapacità colposa o dolosa che, tecnicamente, l’opinione giornalistica e pubblica non può definire.
Credi davvero (che sia sincero) vede una rapida successione di dettagli descrittivi e dialoghi incalzanti che alimentano il pathos letterario e ne fanno intuire la difficoltà nella minuziosa ricostruzione di schemi comportamentali tristemente fissi in fatti sociali complessi, altrettanto mestamente ridotti a qualche trafiletto di cronaca nera o a lunghi servizi televisivi terribilmente vacui.
Nell’incedere di una narrazione che alterna il profondo punto di vista dell’una e dell’altro in un preciso flusso di coscienza, la frase rivelatrice dell’avvenuta e perfettamente riuscita manipolazione, se mai si potesse immortalare come una schermata delle moderne conversazioni, dovrebbe essere proprio quella attribuita dall’autore Roberto Ottonelli a Martina: “Una sensazione mai provata, assurda, quasi violenta.
È tutto così magico, da quando lo conosco mi sento di vivere a cento all’ora, sulle montagne russe.
Il cuore mi batte forte, mi sento viva, desiderata”.
Il repentino gioco a tappe del vessatore con le vite altrui fa sì che Martina viva una sorta di “(…) manuale della giovane innamorata” che, in realtà, ha più il volto del Manuale Diagnostico-Statistico dei Disturbi Mentali (Dsm-V) [4]: nonostante il suo sentirsi “in perenne bilico” e la sua comprensione “(...) dei momenti di buio” dell’ormai già fidanzato Antonio risulta estremamente complesso, specialmente per una persona dalla mente pura e sgombra da qualsivoglia forma di violenza psicologica, comprendere come, nel parco giochi distopico creato tutto attorno a lei, i momenti di su e giù vedano prevalere solo questi ultimi perché anche i centellinati spiragli di libertà, risate, attenzioni, piacere e dolcezza vengono relegati entro ricatti e continue messe alla prova basate sulla deresponsabilizzazione del colpevole dalle proprie perversioni, fughe in avanti verso tradimenti di qualsiasi genere e tipo ed esplosioni di violenza rivelatrice delle sue intenzioni da carceriere rivolte non solo alla compagna, ma anche verso chiunque egli dipinga inferiore perché indifeso come il dipendente in prova presso la sua azienda, da lui umiliato e licenziato.
Nella cruda e paradossale spontaneità delle frasi riportate dall’autore per conto del protagonista Antonio, viene efficacemente riassunta e svelata la servitù volontaria dell’affettività uccisa dall’escalation della violenza manipolatoria.
Per uscirne come cerca di fare Martina, rompendo le catene di convinzioni che il colpevole instilla simili a gocce di veleno nell’incolpevole vittima, bisogna capire al più presto, nel nostro primo percorso individuale, come la felicità di ciascuno non possa e non debba mai dipendere dalle opinioni, dalla volontà, dal controllo e dalle imposizioni altrui, affinché la nostra dipendenza non si traduca mai in potere nelle tutt’altro che disinteressate mani altrui.
Ossia, ogni nostra profonda intuizione sulla minaccia del male verso le nostre e altrui vite, se ricacciata più o meno volontariamente tra le pieghe del nostro animo umano, può divenire pericolosa e persino letale conferma nella continuazione di un disumano abuso.
Quest’ultimo si nutre anche della continua confusione tra il carnefice e la vittima, nell’inversione dei ruoli sulla base di ataviche fragilità e insormontabili insicurezze: trattasi della strana ma continua e utilitaristica pratica della ripetizione di un’infanzia di privazioni e abusi, raccontata dal colpevole alla sua futura moglie con le lacrime a comando che si addicono più a un set cinematografico che alla tragicità dei traumi realmente affrontati.
Eppure, l’escalation del male sembra ormai inarginabile quando porta verso l’inaspettata quanto irrazionale proposta di matrimonio che, paradossalmente, finisce per svelare la totale disistima di Antonio verso la famiglia e le amiche di Martina – le quali insistono sul suo pericoloso cambiamento di personalità –, ree di ostracizzare il rapporto che lui aveva costruito dapprima nella sua mente, comprensivo della distorta lettura di ogni opposizione come attacco e sorta di lesa maestà del suo ormai invincibilmente radicato potere sull’oppressa.
Sono funzionali a ciò anche le continue messe alla prova, le quali vedono il protagonista certo del fatto che “(…) il mio potere prevalesse su tutti gli altri. Esattamente come nella natura stessa del rapporto tra uomini e donne”: questo escamotage letterario, più vicino al narratore che al colpevole, consente però di svelare secoli di sopraffazione patriarcale nemmeno del semplice maschile sul femminile, ma del complesso costrutto sociale estremamente tossico che ci si tramanda, e che sembra solo minimamente scalfito a livello globale.
Il racconto, pur riferendosi a una storia realmente accaduta, non è una fredda cronaca da fascicoli ancora stipati nelle aule di troppi Tribunali ma, al contrario, una sorta di trivella che si cala nel male subìto da Martina, sempre più fiaccata da un dolore psicologico frutto della violenza, come fosse un feto malato cresciuto in un grembo inaridito dall’odio di una mente feroce che manipola la personalità e fa somatizzare nel corpo divenuto anch’esso altrettanto svuotato, violato e oggettivato.
Nell’ingiustizia che sembra stagliarsi inesorabilmente, fino al tragico compimento del suo ciclo, si fa seppur timidamente largo, pagina dopo pagina, la ferale consapevolezza relativa all’inganno da parte di un uomo prevaricatore, dominatore e violento celatosi fino a poco tempo prima dietro la patina del professionista calmo, impeccabile e persino mediamente colto, quanto basta per irretire le vittime.
La consapevolezza di Martina nel voler chiudere una storia d’amore stata tale solo per lei – perché, come scriveva Cesare Pavese nella sua opera Il mestiere di vivere, “(…) la grande, tremenda verità è questa: soffrire non serve a niente” [5] – si esprime con una rabbia diversa da quella del suo carnefice Antonio: è infatti fondamentale distinguere quella della vittima, propria delle fasi di elaborazione del dolore [6], da quella dei perpetratori del corto circuito della violenza, i quali cercheranno quasi sempre di far apparire le proprie nefandezze come movente e “reazione” alle “provocazioni” della prima.
Un epilogo già scritto può evitarsi, per troppe altre storie simili, tenute ancora fuori dalle pagine dei libri, dagli articoli di giornale e dalle pellicole dei teleschermi proprio quando, come descritto in Credi davvero (che sia sincero), si giunge alla certezza del ricatto dietro il tradimento quasi avvenuto e brandito come spada di Damocle sulla fiducia della martire, chiamata a dare continue dimostrazioni delle sue virtù ma mai autorizzata a richiedere altrettanto al partner aguzzino, ormai totalmente assorbito dai bellicosi propositi dettati da un ingiustificato e ingiustificabile complesso di superiorità.
L’incessante messa alla prova da parte di Antonio, nei cui pensieri più reconditi l’autore si cala con inaspettato e cocentemente crudo realismo, non porta mai ad alcuna dimostrazione d’amore bensì al suo esatto contrario, ovvero all’affermazione del dominio che lo spinge discorsivamente ad affermare la volontà di legarla per sempre, sottraendo alla dominata la sua vita precedente mediante lo sfinimento per confermare “(…) fin dove fosse disposta ad arrivare (…)” per lui, nell’attesa che l’ormai effettiva serva volontaria lo ringraziasse persino per la sua stessa riduzione in stato di minorità.
La sottomissione al suo volere passa attraverso una delle tante frasi illuminanti attribuite dallo scrittore a Martina, affermazione che suona come monito per ogni vittima tutt’oggi inconsapevole della pericolosissima rete nella quale è precipitata: “non vedo più nessuno, è solo casa, lavoro e lui. Mi sento soffocare. Non posso andare avanti così, non sono io”.
L’assoggettamento passa proprio per il quando, dove, come e con chi frequentarsi, fino a giungere al totale isolamento dal mondo ormai incarnato solo dal partner abusante e, conseguentemente, all’eclissi totale della propria persona e, soprattutto, della propria individualità come summa della propria coscienza in sé e per sé.
Per chiunque voglia lottare contro la violenza, tanto degli uomini sulle donne quanto, più in generale, del più forte sul più debole, è fondamentale capire come ciò che viene denunciato da queste pubblicazioni e, quotidianamente, dalle realtà come la “Associazione Difesa Donne: noi ci siamo”, fondata dalla madre della vera protagonista della storia insieme ad altre mamme coraggio, non sia una forzatura da narrazione mainstream, ma realtà mentale delle personalità psicopatologiche spinte verso la realizzazione fattiva di ciò che, in base al senso comune e a quello legale, definiamo criminale.
Perché, per tutti i carnefici come Antonio, che giunge all’estremo inganno rivelando in tutto il suo squallore la vera e propria violenza fisica, sessuale e morale, tutte le vittime come Martina non sono né persone umane né donne, né compagne di vita né madri ma, parafrasando delle sentite parole attribuitegli dall’arguta sensibilità dell’autore Ottonelli, “(…) un animale in gabbia, in attesa del momento giusto per attaccare chi si prendeva cura di lui”.
Gli oppressori decidono della vita delle proprie vittime, disponendone fino a un punto tale da consentire, nel loro lucido delirio infarcito da false dichiarazioni d’amore e più tristemente veritieri “ti faccio forse mancare qualcosa?” e “o mia, o di nessun altro”, anche di disfarsene; perché non hanno mai sperimentato e mai sperimenteranno l’amore né, proprio per questo, concederanno ad altri il privilegio di provarlo con loro e nemmeno dopo di loro, con qualcun altro.
Perché i colpevoli come Antonio, nell’alternanza tra finzione narrativa e tragica realtà, hanno unicamente il pensiero fisso e malato di “rimanere solo, la mia paura più grande”; e perché, proprio per questo motivo, sono disposti a qualsiasi bieco inganno e turpe azione pur di blindare i propri sconvolgimenti entro famiglie mai definibili tali, se non nella loro mente deviata, fino all’estremo sacrificio di chiunque sull’altare della loro inusitata volontà.
L’amaro finale di una storia scritta troppe volte, ma propria di un libro che si fa divorare nonostante la difficoltà nell’elaborarlo e l’impossibilità di digerirlo, è impregnata di un senno del poi che insinua il dubbio secondo il quale chissà se i momenti di gioia, le impegnate dichiarazioni d’intenti e le smielate frasi da cioccolatino siano mai state almeno in parte reali, nella mente di coloro che usano e consumano gli altri.
E chissà fino a che punto il senno del tempo venturo possa portare effettivamente a qualcosa, se lo stesso protagonista Antonio, nella descrizione delle sedute di psicoterapia che gli svelarono “(…) il mio tentativo di tacitare le mie paure, avere tutto sotto controllo, prevedere gli imprevisti, anticipare le mosse altrui. Mi sta aiutando molto, ma ormai è tardi”, ammette che ci siano “peccati che non possano essere perdonati” per chi è incapace di provare qualunque sentimento.
Note:
[1] Credi davvero (che sia sincero), di Roberto Ottonelli, edito da Bertoni Editore, prima edizione aprile 2021.
[2] Citazione contenuta in Credi davvero (che sia sincero), pag.7, e tratta dal terzo capitolo del Qoelet o Ecclesiaste, testo ebraico contenuto nella Bibbia ebraica e cristiana (Antico Testamento).
[3] Trattasi di un aneddoto contenuto nel libro dello psicologo e filosofo costruttivista austro-statunitense Paul Watzlawick, intitolato Istruzioni per rendersi infelici, edito da Feltrinelli, 1^ ed. 1984. La storia narra di un ubriaco che, sotto un lampione, cerca qualcosa che sembra aver smarrito. Un poliziotto di passaggio, vista la situazione, si offre di aiutarlo nel cercare le chiavi di casa; dati gli scarsi risultati, quest’ultimo chiede all’uomo se sia sicuro di averle smarrite lì e, per tutta risposta, si sente dire dire di averle perse in un angolo buio in fondo alla strada ma di cercarle lì, per la maggiore quantità di luce. Il racconto di uno dei più grandi esponenti della Scuola di Palo Alto è metafora delle nostre inutili ricerche nell’oscurità di una mente non ancora illuminata e, perciò, impossibilitata a trovare soluzioni utili ai problemi che continuano ad affliggerci.
[4] Acronimo del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Dsm-5), volume standardizzato – ma non scevro da errori storici e conseguenti critiche – adoperato come guida medica mondiale nelle diagnosi, nel trattamento e nella ricerca nel campo della psichiatria.
[5] Citazione tratta dall’opera Il mestiere di vivere, reale diario cominciato dallo scrittore, poeta, traduttore e critico letterario Cesare Pavese nel 1935, periodo di costrizione fascista al confino, e continuato fino a soli nove giorni prima della sua morte, nel 1950.
Edito da Einaudi, 1^ ed.1952.
[6] Le cinque fasi del dolore sono state elaborate per la prima volta dalla psicologa svizzera Elizabeth Kübler-Ross nel 1969, e descritte nel suo libro On death and dying: basandosi sul suo lavoro con i malati terminali, la specialista codificò le fasi popolari del lutto, comunemente denominate diniego, rabbia, contrattazione, depressione e accettazione (Denial, Anger, Bargaining, Depression, Acceptance).