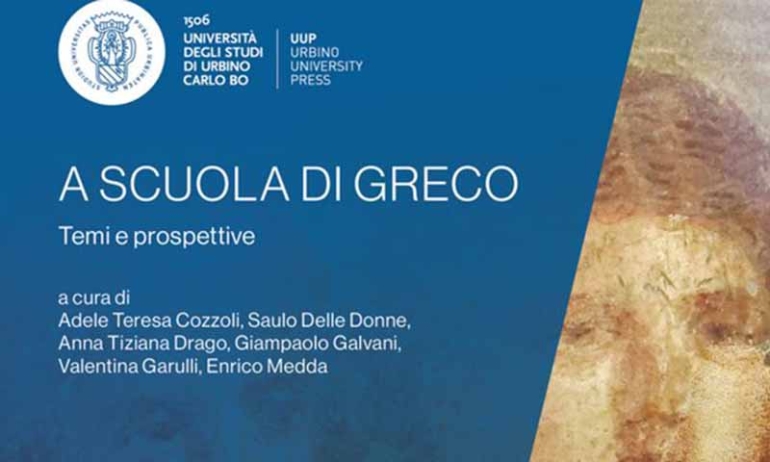Il greco antico rappresenta la base della cultura classica e non è una lingua morta anche se viene considerata tale. Al riguardo molto, però, dipende dalle conoscenze che si hanno ed esiste un’asimmetria che potrebbe essere rimossa e consiste nel fatto che viene studiata come lingua attiva soltanto nei licei classici ed è una criticità del sistema d’insegnamento che ostacola la fruizione per tutti. Fermo restando che i licei classici dovrebbero essere continuamente potenziati, il greco antico potrebbe avere circuiti di fruizione per tutti.
La didattica, quindi, è all’attenzione non solo mirata per i licei classici e università ma anche per un rilancio della cultura classica nella società perché gioca un ruolo importante fuori e dentro le aule dei licei classici e delle università: con innovazioni adeguate potrebbe rilanciare nuovi processi di apprendimento per tutti. Si tenga conto che in Italia ci sono ottimi insegnanti di greco e si saluta quindi con piacere che vari studiosi, docenti universitari e insegnanti dei licei classici, il 15 dicembre del 2023 in un convegno presso l’università di Roma Tre, abbiano presentato i loro studi sulla didattica del greco antico, il 29 gennaio del 2025 sono stati pubblicati gli Atti che hanno per titolo sulla copertina del volume: “A scuola di greco - Temi e prospettive”. Sono stati pubblicati dall’editoriale dell’University Press (Università di Urbino) in open source e sono pubblici sul web [1] e con un costo di € 27 sono disponibili in cartaceo [1].
Il convegno, “L’insegnamento del greco nel Liceo Classico: aspetti e nuove prospettive”, è stato possibile grazie alla sensibilità della “Consulta Universitaria del Greco” con il patrocinio della Fondazione Scuola dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Ha preso spunto dall’attivazione della didattica a distanza che si è affermata per la crisi generata dal Covid-19. Prima di presentare alcune osservazioni si presenta una sintesi ridotta delle relazioni.
Liana Lomiento, docente dell’università di Urbino Carlo Bo e Presidente della Consulta Universitaria del Greco ha aperto i lavori del convegno presentando i saluti ai relatori agli oltre 250 partecipanti e al pubblico che assisteva ai lavori online. Ha detto che in anni recenti sono state avviate numerose iniziative, regionali e nazionali, intese a valorizzare l’importanza della conoscenza delle lingue classiche, iniziative come ad esempio i Campionati di Lingue e civiltà classiche, di cui è attualmente in preparazione l’edizione 2023-2024, e i Certamina (gare) nelle quali, a cadenza periodica, numerosi ragazzi presentano traduzioni di testi cercando di dare buona prova di sé.
Adele Teresa Cozzoli, Università di Roma Tre, ha presentato la prefazione al volume che raccoglie gli Atti del convegno, prima di descrivere le relazioni che qui in estrema sintesi seguono (purtroppo in forma ridotta) ha indicato il 2020 come un anno “epocale” nella storia dell’insegnamento del greco in quanto per ostacolare la diffusione della pandemia si è resa necessaria la didattica digitale. Al riguardo ha osservato che la pratica di analisi e traduzione sul testo per gli esercizi di verifica in classe è stata fortemente penalizzata da questa modalità di erogazione dei corsi scolastici e universitari ma con la convergenza di varie situazioni che si sono create si sta tentando di istituire una sinergia di forze tra scuola e università per delineare le problematiche della didattica del greco e per proporre soluzioni innovative adatte al terzo millennio da trasmettere alle nuove generazioni di docenti. Le 20 relazioni raccolte negli Atti come sono state presentate nel convegno, con lo stesso ordine, sono state pubblicate e sono state divise in 4 sessioni.
Prima sessione:
- Amalia Margherita Cirio, Università La Sapienza di Roma ha presentato “una riflessione sulla didattica di base: attualità degli studi classici” sottolineando la necessità di un insegnamento meno elitario delle lingue classiche e che sia più aperto alle innovazioni intervenute nella didattica delle lingue moderne. Il fine che l’insegnamento del greco dovrebbe perseguire, tanto nei corsi universitari per principianti quanto nelle classi del liceo classico, è quello di fornire gli strumenti necessari per la comprensione del testo, una comprensione che non si limiti ai meri aspetti morfosintattici, ma che dia spazio anche agli elementi culturali e letterari;
- Anika Nicolosi dell’Università di Parma e Angela Benassi docente al Liceo Classico Gian Domenico Romagnosi di Parma, hanno presentato il progetto “Alla scoperta del greco: per un progetto di continuità educativa dalla scuola secondaria all’università” che mira a promuovere la continuità educativa tra scuola secondaria e università per superare il declino delle competenze linguistiche nella lingua madre e la crescente diffidenza verso lo studio della lingua greca antica, risultando necessaria adottare una didattica orientativa capace di guidare gli studenti nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado al liceo classico; il progetto si è posto l’obiettivo di valorizzare lo studio del greco antico dando ampio spazio agli aspetti della cultura greca senza trascurare la lingua che costituisce la chiave di accesso a una più profonda comprensione della civiltà;
- Camillo Neri, Università di Bologna, con “Riflessioni inattuali su quella linguaccia” sottolinea l’importanza di ritrovare il gusto di sperimentare in campo didattico tenendo ben presente che insegnare significa stimolare le passioni dei ragazzi abituando alla fatica che uno studio serio e rigoroso comporta, e quindi per poter migliorare l’apprendimento del greco sarebbe utile anticipare l’insegnamento rispetto a quello del latino nell’ambito di un’ampia riforma dei cicli scolastici che preveda una secondaria di primo grado e rendere l’insegnamento del greco inclusivo, in questo ambito si colloca la sperimentazione relativa all’utilizzo di alcuni software informatici per l’utilizzo del greco politonico (cioè con una tastiera greca) da parte di studenti ipovedenti che è stata attuata dall’Università di Bologna;
- Roberto Batisti, Università di Venezia Ca’ Foscari, ha presentato “Metodi e modelli grammaticali per un apprendimento inclusivo del greco” che attraverso un’attenta disamina dei diversi modelli grammaticali e dei diversi metodi di insegnamento ha messo in luce i punti di forza e le criticità nell’ottica di una didattica rivolta a studenti con bisogni educativi speciali (BES), si tratta di uno spazio particolare riservato al metodo ibrido (cioè, mirato alla fusione tra i corsi in presenza e i corsi online) proposti nel recente manuale Methodos, alla cui redazione Batisti ha collaborato;
- Saulo delle Donne, Dipartimento Studi Umanistici Università del Salento, ha presentato uno studio sul “lessico e sulle grammatiche del greco antico. un tentativo di bilancio quantitativo” dove sono stati esposti i risultati, parziali ma significativi, di un’indagine sulle modalità di insegnamento del lessico proposte da alcune grammatiche in uso nelle scuole e dall’analisi limitata alle unità didattiche incentrate sulla prima declinazione, da cui emerge con chiarezza che i termini utilizzati sono troppo numerosi per poter essere facilmente memorizzati senza considerare che molti di essi presentano un indice di frequenza basso o bassissimo;
- Massimo Giuseppetti, Università Roma Tre, con la sua relazione, “Risorse digitali per un approccio lessicale al greco antico”, ha analizzato come l’Italia si posiziona nel sistema formativo per lo studio della civiltà greco-romana, e non esiste una separazione netta fra l’apprendimento della lingua e lo studio della letteratura o della cultura perché si tratta, da molti punti di vista, di un’inter-relazione che riflette pienamente i caratteri essenziali delle discipline che coinvolge e nello stesso tempo lascia aperta la possibilità che emergano alcune difficoltà;
- Arianna Zanier, Università La Sapienza di Roma, ha presentato il progetto “Theatron. Teatro antico alla Sapienza: per una traduzione e messa in scena del Filottete di Sofocle” che si propone di ricostruire l’esperienza unica del teatro antico, intrecciando competenze linguistico-filologiche e pratico-professionali, descrive nel dettaglio la complessità del lavoro di traduzione per la scena del Filottete sofocleo eseguito dal gruppo “Theatron. Teatro Antico alla Sapienza” durante l’anno accademico 2022/2023.
Seconda sessione:
- Valentina Caruso, Liceo Statale Pietro Calamandrei di Napoli, con la sua relazione “Tradurre ‘per la scena’ e ‘dalla scena’ presenta una proposta didattica sullo Ione (il nome di un personaggio mitologico) di Euripide” ed ha sottolineando lo straordinario successo che le iniziative, per lo più extracurricolari (cioè che non rientrano nel curriculum scolastico, ma contribuiscono alla formazione degli studenti), sono dedicate al teatro e riscuotono nei licei italiani per propone un’analisi della monodia dello Ione (82-103) capace di mettere in luce i molteplici aspetti (linguistici, letterari, ma anche religiosi, etici e performativi) che caratterizzano il testo drammatico;
- Manuela Padovan, Liceo Classico XXV Aprile di Portogruaro, ha presentato un interessante esperimento di applicazione del metodo induttivo attraverso la lettura di un brano di Platone, oggetto della sua relazione: “Leggo Platone. Un’esperienza scolastica per imparare il greco” che ha offerto la relazione di un percorso tramite il quale un gruppo di suoi studenti ha potuto impadronirsi progressivamente di dati storici, culturali e archeologici necessari alla comprensione del passo per poi passare progressivamente al lessico e alle forme linguistiche, con il risultato di acquisire solidamente i dati linguistici trattati e questo suggerisce la possibilità di integrare almeno occasionalmente il metodo induttivo a completamento del tradizionale studio grammaticale;
- Giuseppe D’Alessio, Liceo Classico Vittorio Emanuele di Napoli con la sua relazione “Per una prassi traduttiva consapevole e motivata” ha presentato riflessioni e proposte operative sul fondamentale tema della didattica della traduzione ed ha messo in rilievo che troppo spesso l’esercizio traduttivo viene ridotto a mero strumento per l’accesso alla civiltà greca e si trascura il fatto che esso ha valore formativo in sé, poiché sprona gli studenti a riflettere sui meccanismi di funzionamento della lingua per suscitare l’interesse e la consapevolezza nei confronti della traduzione e suggerisce una serie di attività laboratoriali su testi problematici dal punto di vista filologico e interpretativo;
- Francesca Sbrighi, Rete Nazionale dei Licei Classici, “Il greco nel liceo classico: palestra per il futuro?” nel suo contributo a nome della Rete Nazionale dei Licei mette in evidenza come il saper tradurre costituisca un’importante competenza trasversale perché stimola gli studenti allo sforzo interpretativo, alla riflessione ed al confronto con una cultura altra, in un’epoca segnata dalla velocità, dalla semplificazione ad ogni costo, dall’eccesso di informazioni mordi e fuggi, proprio l’esercizio di traduzione e lo studio del patrimonio di idee trasmesse dalla civiltà greca caratterizzate dai tempi lenti dell’acribia (con esattezza) e della riflessione, possono ancora fornire agli studenti le competenze progettuali necessarie per costruire il loro futuro.
Terza sessione:
- Renzo Tosi, Università di Bologna, con la sua relazione “L’insegnamento della lingua greca come fatto culturale” ha messo in evidenza la netta separazione fra l’insegnamento della grammatica e quello della letteratura e della cultura dall’altro ed ha presentato una serie di esempi concreti nei quali l’apprendimento dei più importanti aspetti morfosintattici come il valore aspettuale, l’uso delle particelle μέν ... δέ, la suffissazione nella composizione nominale, non rimangono fine a se stesso, ma costituiscono il punto di partenza per una riflessione più ampia sui temi, sui generi e su gli autori della letteratura greca;
- Riccardo Palmisciano, Università di Napoli L’Orientale, ha relazionato sul tema “Per un approccio orientato al testo dello studio della lingua e della cultura greca” partendo dalla constatazione che la lingua greca, diversamente dalla cultura greca, allontana e intimorisce buona parte di quanti si cimentano con essa, e formula una proposta didattica basata sulla «frequentazione il più possibile assidua dei testi e dei documenti materiali che siano in grado di far penetrare i giovani negli aspetti più affascinanti della cultura greca». La conoscenza del contesto, infatti, risulta fondamentale per la comprensione dei testi, ma la contestualizzazione può avvenire solo se la conoscenza della grammatica che si accompagna alla conoscenza del lessico, come per gli studi di linguistica funzionale (e cioè, ogni descrizione teorica è finalizzata allo studio delle funzioni comunicative);
- Livio Sbardella e Andrea Ercolani, CNR - Ismed - Università dell’Aquila, hanno relazionato su “Testi, contesti, occasioni. Per un approccio storico-culturale alla didattica del greco” affrontando i problemi legati all’insegnamento della letteratura greca che hanno di recente pubblicato insieme ad altri evidenziando l’importanza di ricostruire accuratamente il contesto sociale, storico e antropologico dei testi, e la tradizionale classificazione per autori e generi dovrebbe essere superata a favore di una didattica della letteratura orientata alla ricostruzione «il più possibile attenta delle occasioni e degli ambienti per i quali i testi erano prodotti e nei quali venivano fruiti, così da favorire una più completa comprensione del sistema della comunicazione della Grecia antica, dalle dinamiche tra autore/performer e pubblico alla pluralità dei codici coinvolti (verbale, musicale, rituale ecc.);
15.Roberto Nicolai, Università La Sapienza di Roma, ha presentato “I testi, la storia e le domande: l'epitafio di Pericle in Tucidide”, una relazione sui testi, intrecciando filologia e storia con un’analisi su più livelli del logos epitaphios di Pericle (Thuc. 2.37) spiegando non solo la funzione che questo discorso svolgeva nell’Atene del V secolo, ma anche le sue modalità di composizione e, attraverso un confronto con altri passi di Tucidide, il concetto di democrazia prospettato dallo storico. Questo tipo di approccio mostra come lo studio attento dei testi antichi, pur dovendo rifuggire dalla dannosa moda dell’attualizzazione, possa comunque fornire strumenti fondamentali per interpretare il presente.
- Andrea Taddei, Università di Pisa, nel suo contributo “Studio della civiltà, apprendimento linguistico e letterario: strategie didattiche” sostiene che una didattica capace di coinvolgere e appassionare gli studenti dovrebbe evitare di presentare il testo come ”un mondo di parole chiuso in sé stesso” e mostrare invece i collegamenti con una molteplicità di contesti. Per perseguire tale fine risulta particolarmente utile un approccio di tipo antropologico con l’antropologia storica che in particolare è in grado di fornire spunti e strumenti utili per capire il contesto in cui i testi della letteratura greca sono stati prodotti.
Quarta sessione:
- Fabio Roscalla, Liceo Classico Ugo Foscolo di Pavia, ha relazionato sul tema “Lingua e cultura nella didattica del greco antico: due obiettivi (in)conciliabili?” ed ha presentato la necessità di modificare la didattica della lingua greca nel primo biennio evitando di ricorrere troppo precocemente alla traduzione di brani che molto spesso sono lontani dal greco autentico. L’insegnamento della lingua, in particolare, non dovrebbe essere funzionale alla sola traduzione, ma potrebbe essere proficuamente utilizzato anche come veicolo di cultura e letteratura;
- Rita Ferrari, Liceo Classico Muratori - San Carlo di Modena, con la sua relazione “Dalle indicazioni nazionali (lingua e cultura greca) alla programmazione” ha parlato di una possibile programmazione del greco esaminando una serie di problematiche e proposte legate all’insegnamento della lingua greca. Tra queste meritano di essere ricordate la necessità di una collaborazione puntuale tra i docenti del primo e del secondo biennio, c’è l’esigenza di selezionare un canone di autori veramente significativi che possano essere trattati nel poco tempo a disposizione, c’è l’urgenza di rendere più snello lo studio della grammatica, senza penalizzare, soprattutto in un periodo in cui le competenze sono più deboli e c’è il bisogno di rendere la traduzione un esercizio consapevole;
- Pietro Rosa, Liceo Classico M. Minghetti di Bologna, con “Didattica del greco e nuovo esame di stato” ha presentato le problematiche che affliggono la didattica del greco con un’attenzione particolare rivolta alle modalità di svolgimento del nuovo Esame di Stato che sebbene meriti di essere conservato in quanto è l’ultimo baluardo di uno studio serio e approfondito delle lingue classiche presenta alcune criticità e necessita di alcuni correttivi come ad esempio la difficoltà del quesito della seconda prova dedicato all’approfondimento e alla riflessione personale che espone gli studenti al facile rischio di accostare testi e autori di epoche diverse o alla difficoltà di far esercitare gli studenti in questo tipo di prova che richiede tempi lunghi che non si hanno a disposizione nel corso dell’anno scolastico, oppure alla superficialità che spesso caratterizza il colloquio pluridisciplinare durante il quale è difficile chiedere ai candidati una riflessione sugli aspetti critici e letterari dei testi proposti;
- Shanna Rossi, Università degli Studi di Palermo - Associazione Antico & Moderno, con la relazione “Verso gli stati generali del liceo classico: riflessioni sul campo” ha ribadito la necessità di un rinnovamento della didattica del greco ed ha presentato le riflessioni e le esperienze che alcuni docenti di greco che hanno esposto in occasione del webinar ‘Le sfide del liceo classico per il terzo millennio’ svoltosi il 18/10/2023, rappresentano i principali ambiti di riflessione come l’uso del digitale nell’insegnamento delle lingue classiche, il rafforzamento delle pratiche didattiche che rendano gli alunni protagonisti del processo di apprendimento e l’analisi di esperienze curricolari ispirate agli ideali della comunità europea;
Chiude il volume un lavoro collettivo con la relazione “Ombre e luci nell’insegnamento del greco attraverso la voce di alcuni docenti” presentata da un gruppo di docenti romani (Anna Pannega, Paola Argenziano, Paola Di Scala, Massimo Gargiulo, Clizia Gurreri, Cecilia Luti, Marco Maiocco, Bianca Daria Manfredi, Ada Mariani, Daniela Pieri) con la quale sono stati analizzati i risultati di un sondaggio mirato a raccogliere informazioni sulla percezione degli insegnanti di greco riguardo alle criticità e ai punti di forza dell’insegnamento della disciplina, l’auspicio lanciato è quello di una proficua intensificazione dei rapporti tra scuola e università.
Nella prefazione di Adele Teresa Cozzoli si presenta il contributo di Giulio Guidorizzi, grecista e traduttore, docente di Letteratura greca presso l’Università di Torino, il cui contributo non è stato incluso negli Atti del volume, nel suo intervento è stata evidenziata l’importanza di avvicinare lo studio del greco alla mentalità delle nuove generazioni sostenendo l’efficacia di una formazione classica come baluardo, anzi come ‘lo scudo di Atena’ e come presidio di civiltà. La letteratura greca, rispetto alle altre, ha qualcosa di assolutamente specifico: non solo è archetipale, ma neanche è pura e semplice letteratura ed è il mezzo principale attraverso cui i Greci trasmisero la loro civiltà. Va quindi trattata con strumenti specifici, a partire dalle forme dell’oralità; può diventare dunque “una stanza del tesoro” da cui si possono estrarre esperienze formative per la crescita umana e non solo culturale dei ragazzi. Perciò la letteratura greca va affrontata con criteri diversi.
Riassumere le relazioni anche se in sintesi ridotta per motivi di spazio è stato necessario per far cogliere ai lettori di questa recensione, anche se non di autore addetto ai lavori, le dinamiche nella fase in corso che stanno agitando la didattica del greco antico come lingua attiva della cultura classica nei licei classici e nelle università. Considerando che non ci sono aperture di nessun tipo riscontrate nelle varie relazioni per una fruizione per tutti al di fuori dei licei classici e delle università si presentano delle osservazioni critiche a conclusione di questa recensione riconoscendo l’importanza di questi Atti nella storiografia della didattica del greco antico. Si inizia presentando due temi che sono all’attenzione di tutti e quindi bisogna tenerne conto: sono l’ignoranza funzionale e l’intelligenza artificiale. L’ignoranza funzionale è quel fenomeno che si manifesta quando si nota che una persona pur leggendo un testo ed è in grado di riassumere però non riesce ad esporre le relazioni tra i significati che il testo presenta, cioè in pratica non riesce a fare critica testuale, attività ordinaria quando si analizza un testo di letteratura greca. L’intelligenza artificiale, per definizione ordinaria riconosciuta, è quell’insieme di tecnologie che consentono ai computer di eseguire una serie di funzioni avanzate, tra cui la capacità di vedere, comprendere e tradurre il linguaggio parlato e scritto, analizzare i dati e fornire suggerimenti. Ci si chiede: come possiamo controllare e verificare i nuovi processi di comunicazione sempre più diffusi tramite l’intelligenza artificiale? Penso che ci sia poco da fare, però possiamo fare verifiche mirate sui testi delle presentazioni se siamo in grado di poterle fare ma dobbiamo avere tutti, gli strumenti adeguati e che siano attivi e continuamente rimodulati in funzione s’intende della nostra formazione culturale per la quale le attività di critica testuale sono il sale del nostro agire politico-culturale e quindi, in estrema sintesi, bisogna che diminuiscono anche se progressivamente quelli che sono oggi i livelli di ignoranza funzionale presenti nella società che purtroppo sono in aumento. Apprendere quindi gradualmente, ma progressivamente il greco antico come lingua attiva a livello di cultura classica può nella società contemporanea dare contributi importanti ed è sbagliato privarsene anche considerando il fatto che in Italia ci sono i migliori studiosi e insegnanti di greco antico a livello mondiale: rimuoviamo gli ostacoli per una fruizione del greco antico per tutti.
Certo ci sono problemi per nuovi progetti d’insegnamento, e ci mancherebbe, certo che sarebbe strano se l’apprendimento del greco antico fosse fruibile per tutti come ordinaria prassi di cultura generale. La lettura di questi Atti che presentano le nuove dinamiche di ricerca sulla didattica dell’insegnamento del greco antico, e che sono ben focalizzate, e che animeranno nel prossimo futuro i corsi di greco dei licei classici, purtroppo, rappresentano l’unica spiaggia oggi disponibile e si spera che resti aperta. La ricerca è iniziata.
Note:
[1] (https://press.uniurb.it/index.php/incontriepercorsi/catalog/book/74).
[2] (https://store.streetlib.com/products.php?productId=607037).