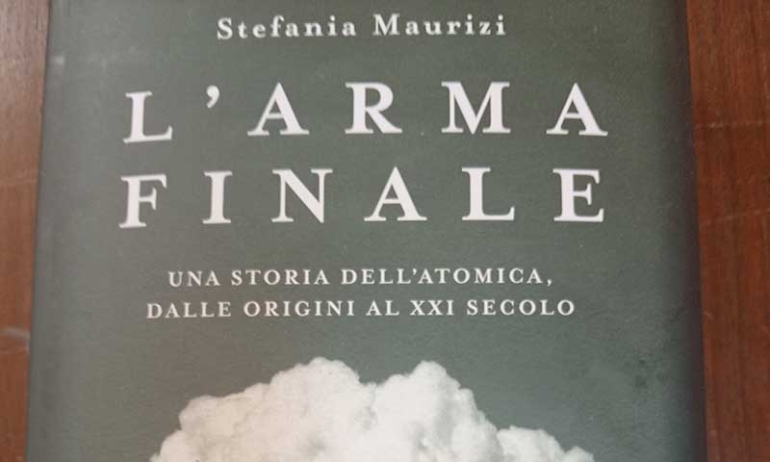Forse nessuno, più del filosofo e “apocalittico consapevole” Günther Anders, primo marito di Hannah Arendt, ha saputo cogliere nel profondo essenza e implicazioni cosmico-storiche di quella che il noto giornalista embedded William Leonard Lawrence battezzò “età atomica” [1]. La ridondante locuzione celebrava l’avvio di una fase della vita planetaria ipotecato dalla scoperta e dall’uso militare dell’energia nucleare, il tornante storico che muoveva dalle fatidiche giornate del 6 e 9 agosto 1945, allorché il Presidente americano Truman decise di impiegare i due ordigni contro l’Impero giapponese di Hiro Hito per chiudere la sanguinosa partita della Seconda guerra mondiale. Critico finissimo della cultura esule negli Usa, prossimo (anche se non organico) alla Scuola di Francoforte e analista meticoloso e implacabile di forme e modi della deriva tecnico-tecnologica della civiltà occidentale e “bianca”, Anders affidava a opere poi diventate imprescindibili [2] (ma lungamente e colpevolmente confinate in una periferia estrema della riflessione critico-filosofica [3]) le sofferte meditazioni sulle iperboli e le perversioni della hybris, che gonfiava le vele narcisistiche di questa parte del Pianeta, a partire dalla trionfale avventura baconiano-galileiana dei secoli XVI-XVII. Quella marciante, secolare e trionfale traiettoria sembrava coerentemente culminare nel parossismo aurorale della bomba atomica che, mentre concludeva vittoriosamente l’epopea della lotta al nazi-fascismo e al militarismo giapponese, apriva tuttavia il cupo scenario di una preoccupante e prevedibile escalation. In essa si sarebbero cimentate in accelerazione progressiva le due superpotenze, in una gara al rialzo, che avrebbe ipotecato minacciosamente i decenni a venire, prendendo il nome di Guerra fredda, ed esponendo l’intera comunità dei viventi all’inaudito dei “rischi finali” [4]. Ma prendeva forma anche un’<<angosciata>> ponderazione dell’eterogenesi dei fini che, colta nella sua dimensione apocalittica da fette consistenti anche se minoritarie di opinione pubblica e di mondo della cultura, veniva tuttavia seccamente sormontata dalla libido dominandi delle classi dirigenti statunitensi, impegnate in una conclusiva operazione egemonica di occupazione integrale dello spazio, geo-politico e simbolico, di cui l’arma atomica costituiva lo strumento principe. Ad essa avrebbero, com’è noto, fatto seguito la reazione e l’inseguimento sovietici, in un piano inclinato che abbiamo imparato a chiamare corsa agli armamenti e che sarebbe sfociato nel famigerato “equilibrio del terrore”, prima di dilatarsi e produrre nel tempo la costituzione di un <<club nucleare>> che conta ad oggi ben nove stati (tra i quali, com’è noto, la formazione sionista) [5].
Se in alcune opere metteva a fuoco la dimensione virtualmente suicida-ecocida e i vertici faustiani dell’acquisizione del dominio umano sul microscopico, in altre Anders complementarmente sviluppava e accreditava il più vasto sfondo teorico di un rapporto tra uomo e suoi prodotti tecnologici, destinato a sanzionare la paradossale subordinazione del soggetto all’oggetto, del manufatto all’artefice, riassunta nella felice locuzione di “gap prometeico” [6]. Disegnava in tal modo il profilo nichilistico di una civiltà, che usciva dalla sartriana “penuria” [7], dall’indigenza della condizione originaria della specie, al prezzo di quelle “perdite secche” [8] sul terreno della auto-valorizzazione umana, che facevano deflagrare le evidenze di un progrediente asservimento universale alla tèchne e lo spettro di un olocausto globale. Quello che veniva prefigurato proprio dai processi di messa resa intensiva e accelerata delle capacità umane di trasformazione e manipolazione del mondo esterno - e che la fabbricazione della Bomba pareva aver limpidamente inverato, più che reso verosimile.
D’altra parte, già la Prima guerra mondiale aveva palesato l’attingimento di una mai prima vista dismisura del mezzo e la demoniaca capacità di escogitazione e materiale produzione di una feroce panoplia distruttiva: dalle stolide enfasi positivistiche su un futuro immaginato come indefinitamente e benignamente progressivo e irreversibile, proprio grazie alla scienza e alle sue applicazioni, la parte più consapevole del mondo intellettuale era così passata alla percezione bruciante di un moltiplicarsi esponenziale delle zone di immanenza di ecatombe e morte di massa. Abbracciato un raggelato disincanto, aveva così preso a denunciare le logiche che governavano il rapporto tra industria e attività militare, le tante contraddizioni tra promesse ingenue di <<sviluppo>> e curvatura tendenzialmente pantoclastica dei suoi corposi riverberi nell’apparato militar-industriale, i rischi di una deriva e di una autonomizzazione dei processi e della <<macchina>>, che sfuggivano al controllo umano o minacciavano di venir subordinati a volontà politiche perverse e prevaricanti.
D’altra parte, le sconvolgenti novità prodottesi nella teoria e nella pratica scientifica, a cavallo tra XIX e XX secolo, l’euforica apertura di orizzonti conoscitivi inediti ed entusiasmanti (si pensi alla quantistica e alla teoria della relatività), se da un lato scuotevano dalle fondamenta le tradizionali certezze della fisica classica, sembravano anche autorizzare nuove enfasi sul dischiudersi di orizzonti conoscitivi prima assolutamente inconcepibili e fertili di sviluppi. E quella formazione sociologica a suo modo cosmopolitica [9], che prende il nome di comunità scientifica internazionale, dislocata che fosse in Germania, Gran Bretagna, Francia, Russia, Italia (in seguito come si sa massicciamente negli Stati Uniti), viveva inizialmente quella accelerazione in una sorta di ebbrezza collettiva e trasversale, prima che l’avvento al potere di Adolf Hitler <<curvasse>> gli entusiasmi più frettolosi verso preoccupazioni di natura politica e morale. Le scoperte della fisica atomica facevano infatti balenare la possibilità dello sprigionamento artificiale di forze immense, e nel ventennio di transizione entre-deux-guerres, col crescere delle tensioni internazionali, il pensiero (non necessariamente di segno unanime, in quel ventennio di asprezze, rancori e premonitori conflitti <<caldi>>) correva facilmente ai possibili impieghi e al <<segno>> di quella risorsa. Insomma, cominciava a porsi il problema dell’uso, di quell’energia, e se nel nuovo Reich germanico (terra di fertilissima ricerca fisica teorica e pratica, dove erano avvenuti eventi decisivi in tal senso [10]) si saldava l’ingenuo fervore innovativo con la atmosfera e l’aspettativa di un riscatto rispetto all’ignominia del tratto di Versailles, negli ambienti scientifici degli altri paesi europei (ma anche in ambienti germanici non omologati) maturava presto il timore speculare, che quelle conoscenze potessero rovesciarsi in una ripresa catastrofica dell’avventura bellica, corroborata dalle realizzazioni possibili della fisica ariana (come essa veniva etichettata dai gerarchi del Regime per contrapporla a quella <<ebraica>>). È questo che motiva la vera e propria corsa alla ricerca delle <<applicazioni>> delle nuove scoperte nel campo della microfisica e ispira e implementa nelle tante personalità di talento la competizione al conseguimento di quella superiorità strategica che potrebbe decidere delle sorti di una comunità, che si vede insidiata dall’aggressività isterizzata del brechtiano <<imbianchino>> e dal revanscismo di un nazionalismo tedesco proiettato alla reconquista del dominio continentale (come prima tappa di un folle disegno di dominio globale). D’altra parte, le prime, grandi conquiste dei nuovi saperi avvenivano proprio in Germania, e i nomi di Otto Hahn, della talentuosa, ma… donna, Lise Meitner, di Werner Heisenberg (ideatore del principio di indeterminazione) e numerosi altri studiosi delle particelle descrivevano un fermento che, innervato dalla belluina e conclamata volontà di potenza del <<Reich>>, poteva sfociare nella sanzione cosmico-storica di una supremazia <<millenaria>>. Era quella dunque la molla motivazionale, non priva di dubbi laceranti e perplessità [9] di una vera e propria marcia forzata degli scienziati <<democratici>> (in numero cospicuo esuli dalle patrie totalitarie) all’ideazione e fabbricazione della Bomba, prima che l’establishment nazista si impadronisse dei segreti dell’atomo convertendoli in mero potere di devastazione.
Le vicissitudini molteplici e multilatitudinarie di quella <<guerra civile degli scienziati>> [10] tra le migliori intelligenze specialistiche dell’epoca, costituiscono un passaggio tanto cruciale quanto dimenticato della nostra traiettoria temporale, e certamente non rappresentano solo un avvincente capitolo di una generica storia culturale, intrecciate come sono allo snodo politico-militare più funesto del XX secolo e ai suoi strascichi geo-politici. Custodiscono tuttavia e descrivono in sé un universo di fatti, vicende e figure, che se pure sembrano oggi perdersi in un passato mitico o sormontati dagli sviluppi successivi, meritano di venir ricordati come esemplificativi delle dinamiche dei rapporti tra potere e mondo intellettuale, tra sapere e potere, così come per quelle interne al multiforme mondo della ricerca, in cui individualità le più diverse possono dispiegare un ventaglio di comportamenti, nei quali entra in gioco la variabile pura della dimensione umana e psicologica, oltre alla questione della moralità dell’impresa scientifica [11].
Ed è proprio questa decisiva temperie della nostra vicenda collettiva <<recente>> che Stefania Maurizi affronta costruendo un saggio che non solo costituisce un’utile ricognizione di storia e sociologia della scienza ma un richiamo potente a <<luoghi>> della contemporaneità riemersi prepotentemente alla ribalta dopo lo scoppio della guerra tra Federazione Russa e Nato (per interposta Ucraina). Tornata infatti disinvoltamente in auge nel lessico politico o politologico, e esondata minacciosamente dallo spazio concettuale della mera deterrenza, la questione dell’arma atomica figura ormai in modo più o meno esplicito nel dibattito giornalistico come uno dei tòpoi di maggiore e drammatica attualità (soprattutto dopo che lo stato coloniale sionista ha sfondato la soglia del dicibile radendo al suolo Gaza e regalando <<numeri>> da romanzo distopico che certificano quanto meno la sospensione del diritto internazionale, prefigurando scabrosi scenari neo-hobbesiani).
Giornalista investigativa dal curriculum più che eloquente, nota anche per aver seguito da protagonista la vicenda di WikiLeaks e di Julian Assange, matematica di professione e dunque sensibile allo specifico di quell’autentica ed esaltante avventura, la Maurizi ne ricostruisce il frastagliato e complesso ambito tematico in una tripartizione che abbraccia la vasta gamma delle problematiche che vi afferirono e afferiscono. Intanto lo stato dell’arte, cioè il chi e il come, oggi, governa l’immenso arsenale, che pone in forse, con <<l’era dell’Armageddon>> (p. 39), la possibilità stessa della perpetuazione della vita sul pianeta, annunciando il punto estremo di non ritorno, dell’annientamento globale. I dati quantitativi e qualitativi sulla distribuzione degli ordigni e le vicende relative ai tentativi di regolamentazione e ai trattati di non-proliferazione, cui le superpotenze pervennero nelle varie fasi della guerra fredda, nelle periodiche oscillazioni e contingenze che contraddistinsero le loro relazioni, fino ai primi anni Novanta e oltre, all’attuale zona di rischio. L'abbrivio aurorale di quel <<racconto pieno di paradossi, contraddizioni e misteri>> che descrive la <<storia della prima bomba>> (p. 15), risalendo alle fasi primitive della ricerca già ai primi del secolo XX, col salto inventivo sulla radioattività (dapprima naturale, poi artificiale), che porta i nomi dei fisici francesi Henri Becquerel, Marie e Pierre Curie, dell’inglese Rutherford), poi con la scoperta del neutrone (per merito di James Chadwick nel 1932). Fino alle più recenti, deliranti evocazioni dell’uso in chiave tattica sul territorio di Gaza, come quella di ministri del governo Netanyahu [12].
Quindi, la genesi drammatica e l’ampia, concitata e movimentatissima traiettoria organizzativa e la strettoia a partire dalla fine degli anni Trenta, allorché la lunga volata finale indotta dallo scoppio del Secondo conflitto mondiale traduce le euforie teoriche in concreti programmi di conversione e impiego militare. Vicende a suo tempo estesamente raccontate nel <<vecchio>> testo di Jungk, e dalla Maurizi ricondotte alla loro bruciante e vivente attualità, nell’obliquo incrocio tra diacronia e sincronia e nella descrizione delle tante tipologie esistenziali degli agenti implicati, vero campionario di vizi e virtù, di talento e miserie umane, di squallore e grandezze, ambizioni e senso del limite vissuto con consapevolezza e dubbi dilanianti, forme di opportunismo e assillanti tormenti per gli esiti della guerra, talora distrazione e apolitica leggerezza. I nomi di Robert Oppenheimer (direttore del laboratorio di Los Alamos, riportato recentemente in auge dal film del 2023 di Christopher Nolan) e del <<nostro>> Enrico Fermi sono soltanto esempi mediaticamente rilevanti di quel Gotha intellettuale che stravolse i destini della contemporaneità e che non fu certamente unanime nell’abbracciare la scelta del governo Usa di bombardare le due città giapponesi [13]. Divisa e incerta, quella costellazione di <<cervelli>> non fu comunque in grado di modificare le volontà politiche retrostanti, mosse da finalità altre, che obbedivano a una volontà di potenza del tutto estranea a pulsioni di ordine conoscitivo e men che meno <<morali>>.
Infine, l’Autrice propone le interviste di dieci figure di scienziati e scienziate, direttamente coinvolti nell’impresa atomica, esemplificative di opzioni ed emozioni, scelte e dilemmi morali connessi, non per una generica curiosità biografica o esegetica, bensì per illustrare la gamma delle possibilità e difficoltà esistenziali, con le quali molti di essi dovettero misurarsi, assai spesso non riuscendo, o non volendo affatto, per ragioni le più diverse, sottrarsi alle logiche sovradeterminanti dell’epoca, alla subalternità rispetto al committente (il governo degli Stati Uniti).
Dunque una ricognizione ad ampio spettro, quella della Maurizi, perfettamente all’altezza della problematica filosofica finale della questione, coinvolgente i destini della specie e il piano inclinato intrapreso a suo tempo dall’impennarsi delle capacità tecniche di governo della realtà fisica da parte delle élites accademiche.
Problematica non risolta, bensì complicata dalle recenti, superficiali retoriche dell’Intelligenza Artificiale, che pretenderebbero di semplificare, in un vero delirio scientistico, i processi che strutturano il governo mentale della realtà, poiché <<l’ingresso dell’intelligenza artificiale nell’ancestrale “arte della guerra” ha introdotto un nuovo terrore nel vecchio incubo dell’Armageddon>>. Se, infatti, <<in passato le armi nucleari fossero state controllate dall’intelligenza artificiale, tutti noi saremmo già morti>> (p. 30), scrive il citato Bulletin of the Atomic Scientists, ripercorrendo l’eloquente episodio (ma solo uno dei tanti) che ebbe per protagonista il tenente colonnello sovietico Stanislav Petrov, <<l’uomo che salvò il mondo>>, allorché reagì, lui sì creativamente, nel settembre 1983, al falso allarme proveniente dalla strumentazione elettronica, che indicava l’imminenza di un attacco americano, ragionando sull’effettività logica di quanto derivava dai dati e applicando <<la mente acquisitiva di chi diffida di algoritmi e programmi software, perché consapevole che sono soggetti a errori>> (p. 29). L’ennesima ragione per invocare le ragioni di una politica sottratta alla sovra determinazione degli Arcana Imperii e del complesso militar-industriale e delle scorciatoie tecnicistiche, in un mondo che sembra delegare le proprie inadeguatezze a specialismi presuntamente neutri, galleggia sulla banalizzazione esaltata dell’apparato tecnico-scientifico e sdrammatizza la questione della <<fine del mondo>> come petizione di principio di visionarie anime belle.
Note
[1] Premio Pulitzer nel 1946, il giornalista statunitense fece disinvoltamente suo, sul “New York Times”, il compito di bagattellizzare come “propaganda giapponese” gli effetti di medio-lungo periodo della prima esplosione atomica. Di poco precedendo la rassicurazione del responsabile dell’intero progetto, il generale Leslie Groves, secondo il quale <<la morte a causa della radioattività è ‘un modo molto piacevole di morire’>> (p. 14).
2] Della vastissima bibliografia del filosofo tedesco segnaliamo qui solo i due volumi de L’uomo è antiquato (Torino, Bollati-Boringhieri, 2003), e L’uomo sul ponte. Diario di Hiroshima e Nagasaki (e Tesi sull’età atomica) Milano-Udine, Mimesis, 2024).
[3] Vanno ricordati e fanno eccezione, prima di tutto, oltre gli interventi di Norberto Bobbio, i saggi che lo storico Luigi Cortesi ha dedicato all’inquieto pensatore tedesco e alla <<condizione atomica>>, raccolti nel tempo oltre che nella rivista <<Giano. Pace ambiente problemi globali>>, in Le armi della critica. Guerra e rivoluzione pacifista , Napoli, 1991, Una crisi di civiltà. Cronache di fine secolo, Napoli, 1999, e soprattutto Storia e catastrofe. Sul sistema globale di sterminio , Roma, manifestolibri, 2004.
[4] L’espressione è di Luigi Cortesi (v. sopra, passim).
[5]Oltre Stati Uniti e Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna, Israele, India, Pakistan e Corea del Nord.
[6] In L’uomo è…, passim.
[7] In Critica della ragione dialettica, Milano, il Saggiatore, 1963, Libro I, pagg. 248-265.
[8] V. Cortesi, Una crisi di civiltà…, passim.
[9] Si veda il pionieristico Robert Jungk, Gli apprendisti stregoni. Storia degli scienziati atomici, Torino, Einaudi, 1958, complemento insostituibile al libro di Stefania Maurizi, il cui titolo icastico è evocativo di una figura esemplare e ultracentenaria della nostra cultura.
[10] Jungk, cit. pag. 325.
[11] Pensiamo, prima di tutto, ma la lista sarebbe assai lunga, alle figure geniali e inquiete, di Otto Hahn (scopritore, con Lise Meitner, della fissione nucleare) e Leo Szilard (vero profeta inascoltato dell’inopportunità dell’uso del manufatto sulle città giapponesi). O a quelle, ciascuna a suo modo estrema, del padre della <<Superbomba”, l’oltranzista ”atlantico” Edward Teller, o al “collaborazionista” John von Neumann, “vera e propria prostituta della scienza”, nelle parole di Piergiorgio Odifreddi, il fisico che “ispirò il personaggio del Dottor Stranamore di Stanley Kubrick” (pag. 127).
[12] “… soluzione prospettata anche da un membro del Congresso americano, secondo cui gli Stati Uniti avrebbero dovuto bombardare Gaza come Hiroshima e Nagasaki”, pag. 25. Piace qui ricordare il caso del tecnico israeliano Mordechai Vanunu, impiegato nella centrale nucleare di Dimona, che “nel 1986, a soli trentadue anni, rivelò al quotidiano inglese <<The Sunday Times>> la vastità del programma nucleare militare del suo paese, su cui il governo continua a mantenere un’assoluta opacità: Israele non ha mai ammesso di essere una potenza nucleare”, pag. 32. Rapito in Italia da agenti del Mossad, Vanunu venne trasportato furtivamente in Israele, processato in segreto per tradimento e spionaggio e condannato a 18 anni di reclusione. Liberato nel 2004, Vanunu è da allora sottoposto a un regime vessatorio, che ne limita in modo estremo quasi ogni libertà di movimento. Cfr. Eric Salerno, Mossad base Italia, Milano, il Saggiatore, 2010.
[13] Ci riferiamo al cosiddetto Rapporto Franck (dal nome del Nobel omonimo) che, nel maggio 1945, “oltre a suggerire l’uso dimostrativo della bomba, proponeva una serie di linee guida per la gestione delle armi nucleari dopo la fine della guerra”, pag. 128. La petizione correlata, stesa da Leo Szilard per sollecitare in tal senso il Presidente Truman, venne firmata solo da una parte della folta equipe scientifica. “In ogni caso Truman ignorò la petizione e decise di procedere con l’uso contro le popolazioni civili, anziché con quello dimostrativo”, pag. 129.