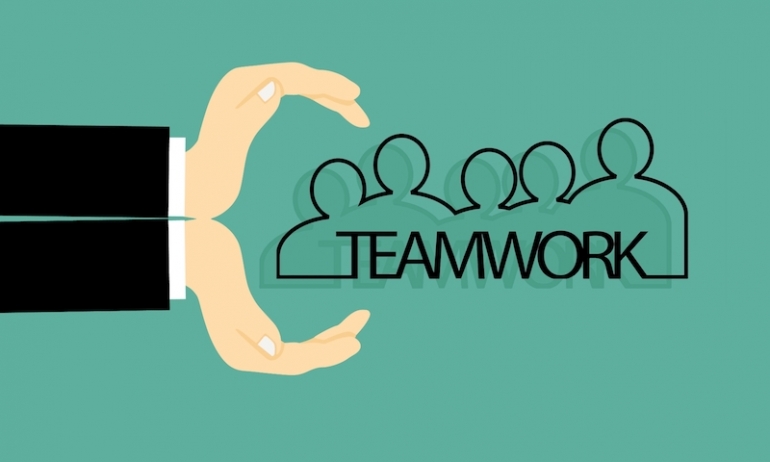Il 16 luglio scorso sul Sole 24 Ore, quotidiano della Confindustria, che si è distinta in questa fase per le pressioni sul governo per il proseguimento dell’attività produttiva anche non “essenziale”, è uscito un interessante inserto “guida Impresa Smart”, dedicato a come le aziende cambieranno in seguito alla massiccia introduzione del digitale. La guida è stata realizzata grazie alla collaborazione della School of Management del Politecnico di Milano (tutti gli anglicismi sono originali) e si pone come obiettivo quello di comprendere e di dirigere le opportunità offerte da queste rilevanti trasformazioni tecnologiche, pur ovviamente restando immutato l’obiettivo finale: il profitto, anzi magari facilitandone l’ottenimento e aumentandone l’entità.
A mio parere la pubblicazione rivela un significativo cambio di paradigma, ovviamente ulteriormente antidemocratico, nella gestione delle aziende, che cercherò brevemente di illustrare, segnalando come questa virata sia sostenuta ideologicamente dal mondo accademico organico alla Confindustria.
Il problema fondamentale, indicato nell’articolo “Impegno e scopo le parole chiave per la leadership” di Antonio Dini, pubblicato nell’inserto, è quello del cambiamento delle persone, ossia di introiettare una sorta di nuova morale del lavoro, con il rischio che se questo processo fallisce le grandi trasformazioni tecnologiche risulteranno inefficaci.
Credo che proprio queste due parole “impegno e scopo” meritino una qualche riflessione, soprattutto dopo che per decenni si sono aspramente criticati i cosiddetti “intellettuali engagés” (impegnati), accusati di essere sottoposti a verità imposte dall’alto, estranei a un sano pragmatismo di matrice statunitense, che individui i mezzi adeguati a risolvere i problemi, senza interrogarsi sulla natura e sulla legittimità di della loro impostazione e senza prospettare progetti a lungo termine. Che in molti casi questa accusa si sia dimostrata del tutto inconsistente è evidenziato dalla vicenda politica e umana di Jean-Paul Sartre, icona dell’intellettuale impegnato ma indipendente, che nel 1964 giunse a rifiutare il premio Nobel per la letteratura, dopo aver rifiutato l’onorificenza della Legion d’onore e una cattedra al prestigioso Collège de France.
Dietro la vicenda di Sartre sta la celebre disputa, che ha innervato gran parte del dibattito culturale del Novecento, tra “intellettuali puri”, dediti solo alla ricerca della verità (quale?), e “intellettuali rivoluzionari”, in lotta per rovesciare il potere vigente e quindi politicamente “schierati”.
Questa disputa, i cui antecedenti riguardano la relazione tra politica e cultura già toccata da Platone, prende le mosse dalla riflessione di Max Weber, sostenitore della avalutatività della scienza, e dalla distinzione fatta nel 1916 da Vilfredo Pareto tra “scienziati” e “apostoli”, distinzione sostanzialmente condivisa da Benedetto Croce.
Naturalmente tra gli apostoli viene spesso annoverato anche Karl Marx, la cui riflessione è stata sempre tacciata di messianismo e di utopismo da parte di coloro che si sono mossi in un’ottica blandamente riformistica e di corto respiro.
Ora, come mostra in maniera irrefutabile la storia del capitalismo e dei suoi apologeti, che lo descrivono come il migliore dei mondi possibili per la sua capacità di garantire la “piena libertà” e “l’effettiva realizzazione dell’individuo”, la classe dirigente ha sempre dato la sua preferenza agli “intellettuali puri” e soprattutto avalutativi e pragmatisti; e ciò per evitare il duplice rischio che, da un lato, si disvelasse il fine della produzione capitalistica, dall’altro, se ne mettessero in luce i gravi svantaggi per i produttori-lavoratori, evidenziando allo stesso tempo la contraddittorietà tra gli obiettivi dichiarati e quelli effettivamente ottenuti. Insomma, l’intellettuale deve ricercare la soluzione dei problemi immediati, indicando misure parziali e per questo insoddisfacenti, ma mai interrogarsi sulla loro natura storico-sociale e quindi sulla loro origine, in uno scenario in cui il sistema non viene mai messo in questione, dato che tutt’al più può essere migliorato, edulcorato, depurato delle sue asprezze.
Dinanzi ai gravissimi problemi con cui oggi ci scontriamo e che sono stati partoriti dallo stesso sistema basato sull’industrialismo capitalistico, solo inaspriti dalla pandemia in atto, la classe dirigente internazionale, largamente sfiduciata dalle masse popolari e da esse separata da un incolmabile fossato, si gioca una nuova carta. Dichiara di voler abbandonare il modello tradizionale dell’azienda gerarchica, che recluta i lavoratori alternando l’uso del “bastone e della carota”, e invita i suoi esponenti ad esercitare “una leadership differente, di tipo carismatico e meno burocratico-razionale”, fondata – come si è già detto sull’engagement e sul purpose (impegno e scopo).
Detto in soldoni ciò vuol dire – nelle parole dell’autore dell’articolo – che occorre essere più motivati, indicando ai dipendenti uno scopo, che “esprime un valore superiore a quello del semplice profitto (che certamente rimane, ma non è più l’obiettivo)”. Di scopi Antonini ne indica due: il primo è ovviamente condiviso da tutti e consiste nel salvare l’ambiente, solo che per realizzare questo lodevole obiettivo bisognerebbe, per esempio, cambiare radicalmente il sistema produttivo agroalimentare, e abbandonare le politiche di espoliazione imperialistica del Sud globale, dove continua a crescere una popolazione sempre più misera, non adeguatamente sostentata per l’uso irrazionale delle risorse. Ovviamente se si portassero avanti sul serio questi cambiamenti si sgretolerebbe il sistema economico-sociale nel suo complesso, e non credo che il Sole 24 Ore intenda mettersi su questa strada.
Il secondo scopo proposto per questo cambiamento culturale è, invece, rappresentato proprio dall’impiego irrazionale delle risorse, cui prima si faceva riferimento; infatti, esso è così definito “vendere prodotti appartenenti al mito”, forse si voleva dire cult. Tali prodotti sono anche definiti “semplicemente molto belli” e si incarnano, per esempio, negli oggetti messi sul mercato da Tesla, azienda innovatrice produttrice di veicoli elettrici, Ferrari, Apple, e non sono certo accessibili a tutti. Insomma, proponendo scopi più alti (?) del gretto profitto, si pensa che i lavoratori li condivideranno e daranno anche l’anima per la loro realizzazione, sotto la guida di un capo carismatico che è stato capace di motivarli e per il quale saranno disposti a lavorare “con entusiasmo a ciclo continuo”.
Vorrei aggiungere un’altra considerazione su questo secondo scopo, il quale senza nessun pudico tentativo di occultamento incita ancora una volta gli individui al consumismo, magari un consumismo di alta qualità, cui solo pochi possono dedicarsi, imprigionandoli nel trito mito che fa dell’oggetto il simbolo del proprio status sociale. Consumismo, costituito in larga parte dall’accesso a oggetti del tutto inutili e superflui, su cui oggi si basa circa l’80% della produzione industriale e la tanto bramata crescita, che l’attuale crisi ha fortemente incrinato.
Lo scivolamento verso la figura del capo-carismatico, basata sulle capacità personali dell’eletto, che può avere anche un ruolo fortemente negativo (si pensi a Mussolini e a Hitler), è assai pericoloso, perché implica il riconoscimento sottinteso – seguendo la terminologia weberiana – della crisi dell’autorità legale-razionale, che attribuisce un certo ruolo sulla base di procedure riconosciute come legittime. L’acuirsi delle ineguaglianze mette fortemente in questione il diritto alla leadership, alla proprietà, e rende assai difficile giustificarne la legittimità in un contesto come quello attuale in cui prevaricazione, corruzione, violazione degli stessi fondamenti della convivenza umana sono purtroppo dominanti. D’altra parte, se non è più possibile ricorrere a questa forma di legittimazione, non rimane altro che fornire una base del tutto irrazionale alla propria preminenza, individuata in quel certo non so che (carisma) di cui alcuni sarebbero dotati rispetto agli altri. Tuttavia, a differenza di quello che ci vogliono far credere, soprattutto nell’epoca delle comunicazioni di massa, il carisma non è un dono fortuito, ma un’immagine sociale costruita mettendo insieme vari aspetti della personalità, magari indulgendo anche su i lati più intimi, che umanizzano e rendono più accettabile il personaggio celebrato.